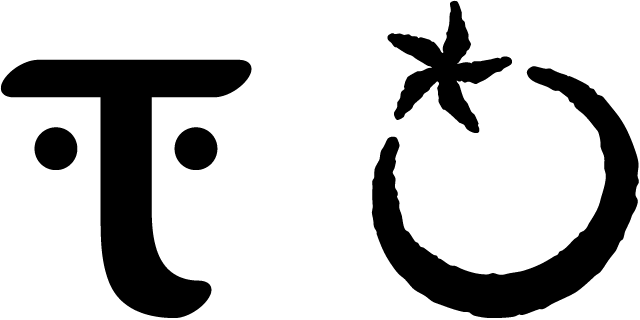Inni, stornelli, danze, jazz, marce, riviste teatrali. L’Etiopia è stata cantata in molti modi nella seconda metà degli anni Trenta, eppure di questo repertorio non è rimasta traccia, se non nelle celebrazioni nostalgiche e neofasciste. Ripensare il ruolo della musica e dei musicisti nel generare il coinvolgimento di un’intera nazione è tuttavia fondamentale per comprendere i meccanismi alla base di una rimozione collettiva e della persistenza di un immaginario coloniale e razzista.

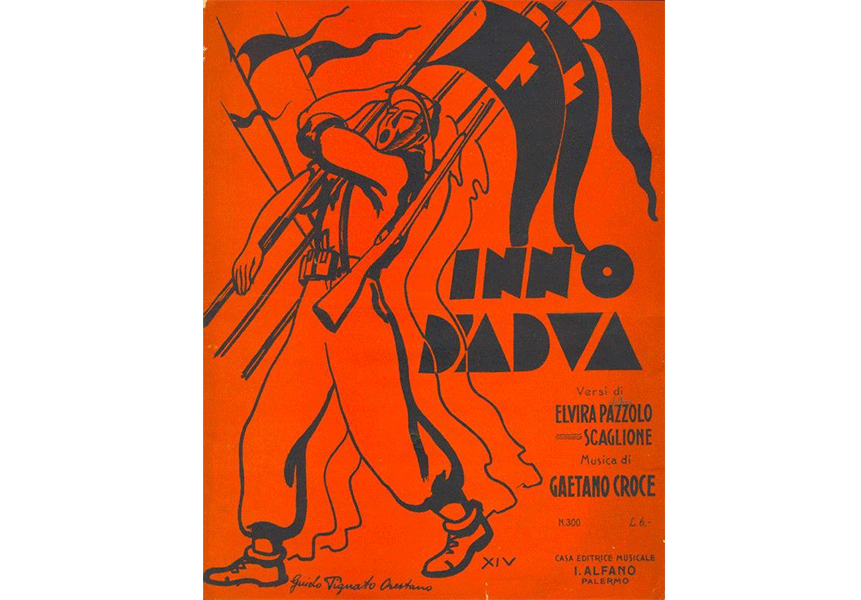
«Attraverso una serrata analisi di Faccetta nera [nonché di tutto il repertorio che qui si presenta, aggiungerei] si potrebbe destrutturare il testo, decolonizzare le menti, defascistizzare la società, educare la nostra politica che ormai ha fatto dell’altro il capro espiatorio per eccellenza».
Gianpaolo Chiriacò è ricercatore presso l’Università di Innsbruck. Muovendosi fra etnomusicologia e cultural studies, ha portato avanti una lunga ricerca sul campo a Chicago, (Voci Nere. Storia e antropologia del canto afroamericano, Mimesis 2018) e adesso indaga le relazioni fra Italia ed Etiopia nella popular music italiana. Nel resto del tempo si prende cura delle sue figlie.
www.afrovocality.com