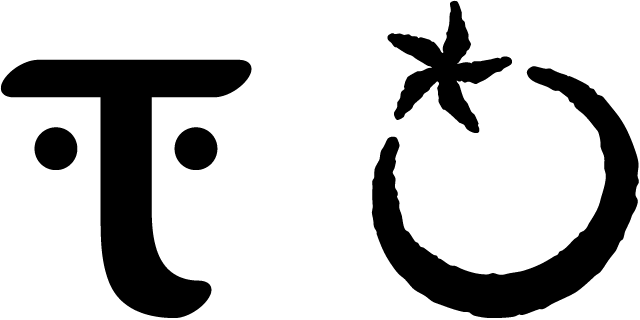Per una politica della responsabilità
L'ennesimo femminicidio sta scuotendo l'opinione pubblica italiana. La risposta maschile, anche se più diffusa che in passato, è ancora timida nella messa in discussione personale e lontana dal ragionamento sul che fare. Mentre le parole e il linguaggio di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, hanno chiamato in causa direttamente gli uomini, bisogna chiedersi se c'è spazio per una rappresentazione maschile che abbandoni l'idea dell'eccezionalità deviante da curare e apra alla possibilità di una pratica di cura collettiva delle relazioni e della società tutta.
Manchevole della stessa forma di empatia, forse un po' per una questione caratteriale, un po' perché maschio (e non è una coincidenza così originale...), ho avuto bisogno di uno strappo più forte, quello che Elena Cecchettin ha provocato con le sue parole infiammate, con quel richiamo alla responsabilità maschile, con quel suo «Nessun uomo è buono se non fa nulla». Un richiamo così politico, esplicitato con un linguaggio ed un lessico che sarà risuonato più che familiare a tutti coloro che come me, anche solo per brevi periodi della propria vita, hanno frequentato gli spazi della politica dal basso, le assemblee, i movimenti. Luoghi in cui l’antisessismo è sbandierato a ogni occasione come un principio non secondario andando a costituire quella santa trinità movimentista insieme ad antifascismo e antirazzismo. È stato necessario questo strappo per decidere di non fermarmi alla consueta tiepida e quasi dovuta reazione di leggero intristimento e fastidio. È stato necessario questo strappo per mettere giù alcune riflessioni che da qualche tempo mi girano in testa, perché alla fine gli amici con cui parlarne sono sempre pochi (e pochi i momenti che sembrano propizi) e l'assemblea non si riunisce più da un anno perché ognuno ha i suoi impegni e la sera si è sempre stanchi. E, alla fine, nella solitudine di maschio non ne parlo quasi più con nessuno.
Parto dalle parole di Elena, senza alcuna pretesa di dare lezioni o proporre ricette e con la consapevolezza di tentare un discorso che non può essere che parziale, con il desiderio di contribuire al dibattito, per tenere acceso il fuoco.
Dico allora che da uomini dobbiamo sforzarci di portare il conflitto fra gli uomini, innanzitutto nei rapporti più importanti e vicini, laddove sentiamo che è più difficile perché maggiore è il rischio di comprometterli.
Nella lettera che Elena Cecchettin ha scritto trasformando la sua sofferenza privata in discorso politico viene messo nero su bianco il tema del cameratismo maschile. Ogni uomo che a partire da un sentimento di fastidio riconosce la distanza anche dal più piccolo dei comportamenti sessisti dovrebbe agire, interrompere il perpetuarsi della loro normalizzazione, rompere la parvenza di una complicità maschile generalizzata. Dico allora che da uomini dobbiamo sforzarci di portare il conflitto fra gli uomini, innanzitutto nei rapporti più importanti e vicini, laddove sentiamo che è più difficile perché maggiore è il rischio di comprometterli. Contestiamo allora i modi di dire sessisti e omo-transfobici di padri, zii e cugini più grandi. Rifiutiamo le battute degli amici di vecchia data coi quali il sentire è reso forte dagli anni di conoscenza ma i percorsi di vita si sono separati per cause varie. Dissociamoci da un certo modo di fare fra maschi sul luogo di lavoro con i colleghi con i quali si è creato quel feeling che rende quello stesso lavoro sopportabile. Cito i piccoli atteggiamenti, le violenze «minute» per un motivo preciso: è fondamentale riconoscere, in primo luogo con noi stessi, il legame indissolubile fra cultura patriarcale e violenza sessista, quindi denunciare il nesso tra la cultura dello sminuire (le donne) e la legittimazione della violenza (sulle donne). È fondamentale riconoscerlo nell'efficace figura di un ponte sull'abisso che separa la maggioranza maschile da un femminicida o di quella dell'aria tossica che tutti respiriamo in piccole dosi quotidianamente e che di tanto in tanto (ma continuamente) avvelena qualcuno irrimediabilmente. Non ci sono mostri né pazzi, la questione ci riguarda tutti.
Eppure dico questo a partire da una grande fatica personale. Che cosa mi impedisce di interrompere il circolo vizioso di un disagio (per quello che sento) che chiama altro disagio (per quello che provo)? Cosa rende tanto difficile evitare la risata compiacente all'ennesima battuta sessista se sentiamo chiara la distanza da modi di dire che non ci appartengono più? La nostra risata apparirà comunque tirata. Aprire e assumersi il peso in un conflitto è qualcosa che può certo anche comportare sofferenza (e su questo ritornerò) ma è anche ciò che apre alla possibilità del cambiamento. Pensiamo al nutrimento, al bene che può portare a quelle stesse relazioni l'opportunità di uscirne liberi, sollevati, scoprendoci forse più vicini di quanto si credeva, schermati dagli stereotipi e dalle aspettative sociali (fratello non sei il solo!).
Una questione generazionale?
Nelle riflessioni più o meno collettive a cui ho partecipato è emerso spesso il tema generazionale: è convinzione diffusa che quello della violenza di genere sia un problema che derivi dalla cultura ereditata, mentre in quella delle nuove generazioni, dei più giovani, sono evidenti i segni di un cambiamento nel concepire più fluidamente i rapporti fra i generi, l'identità sessuale, i confini delle relazioni affettive e di coppia. Con la diffusione delle sperimentazioni poliamorose e la minore invisibilizzazione che sembrerebbero avere nella società le persone lgbtqia+, potrebbe essere solo questione di tempo, di attendere che la ruota giri: il vecchio mondo morirà con i suoi rappresentanti.
Sperare che tutto si sistemi da sé nasconde, neanche troppo efficacemente, un alibi per la nostra (generazionale) incapacità di agire. Ma, soprattutto, tale pensiero ci impedisce di vedere come questo cambiamento di mentalità, che non voglio affatto negare, stia già provocando una maggiore polarizzazione fra vecchie e nuove culture relazionali: dentro le coppie e gli affetti, nelle amicizie, nelle famiglie e nella società tutta. Il fatto che molti di questi episodi di violenza riguardino proprio persone molto giovani o giovanissime dovrebbe farci riflettere in questo senso. Il rischio è quello che si allarghi e radicalizzi un conflitto che, all'opposto di quanto si spera, rende ancora più urgente lo sviluppo e la condivisione di strumenti e di capacità di analisi, quindi la creazione di luoghi adatti a generare confronto. Non si può lasciare infatti alla solitudine delle vite vissute diversamente il prezzo del cambiamento in atto. Il conflitto e tutto il suo potenziale trasformativo, se lasciato a se stesso, non può che sfociare al contrario nella violenza e nella guerra. Mi chiedo e vi chiedo se siamo disposti a contare i caduti.
Siamo cresciuti (noi maschi soprattutto) secondo modelli di vita, raccontati come efficaci e desiderabili, votati al successo individuale a scapito di tuttə lə altrə. La coppia e le relazioni primarie rischiano di diventare il rifugio dove l'esercizio del potere è lo sfogo per l'insostenibilità della nostra solitudine individuale.
Quanto si è letto sui giornali a seguito dell'accaduto fa pensare che il comportamento violento che Filippo Turetta ha messo in atto nei confronti di Giulia Cecchettin e di cui l'assassinio sarebbe stato solo l'epilogo abbiano a che fare con la paura dell’abbandono. Questo ci permette di tornare sull’ineludibile tema della solitudine maschile. Non serve qui spiegare perché la costruzione del genere maschile sia da sempre caratterizzata da questa difficoltà nel condividere i propri vissuti e nell'esternare le personali fragilità. Forse però serve rimarcare la natura sociale di tale predisposizione. Siamo cresciuti (noi maschi soprattutto) secondo modelli di vita, raccontati come efficaci e desiderabili, votati al successo individuale a scapito di tuttə lə altrə. La coppia e le relazioni primarie rischiano di diventare il rifugio dove l'esercizio del potere è lo sfogo per l'insostenibilità della nostra solitudine individuale. Nel momento in cui si inizia a percepire una minaccia all'esistenza di tale rifugio – minaccia troppo spesso individuata nell'affermazione della libertà femminile – sopraggiunge una crisi della presenza e l'agire violento quale estremo e tragico tentativo di difesa. Atteggiamenti quali gelosia e ossessione del controllo sono manifestazioni minori della stessa condizione di precarietà esistenziale e individualismo poste a fondamento della società nella quale viviamo, che si saldano nelle relazioni fondamentali. Principi e modelli tossici che non possono essere esclusi dagli obiettivi di un'azione volta al cambiamento.
Prendersi cura
La necessità di dissociarsi dalla cultura patriarcale, l'apertura di spazi di conflitto congenere, i rischi di una messa in dubbio delle relazioni fondamentali che queste azioni possono provocare e la costitutiva solitudine maschile impongono che tutto ciò sia accompagnato da un'importante assunzione di responsabilità collettiva nei confronti del cambiamento. Una risposta che penso debba passare attraverso la diffusione di pratiche di cura promiscua, la creazione di comunità co-responsabili e la proliferazione di collettivi quali luoghi di esercizio ed educazione al conflitto generativo. Avere cura delle relazioni e dell'ambiente in cui esse prendono forma è precondizione necessaria al cambiamento maschile. Praticare, diffondere ed educare a una cultura affettiva rispettosa delle differenze e consapevolizzante circa le difficoltà e le fragilità che l'incontro con lə altrə comporta. Esplorare e prendere sul serio l'amicizia quale luogo precipuo per l'apprendimento dello stare in relazione nel rispetto dell'altrui libertà. Avere cura dei nostri amici maschi, dimostrare di esserci per loro, fugare i timori di abbandono senza commiserazione e pacche sulle spalle. Sono alcuni suggerimenti che mi sento di contrapporre alla conta delle morti.
Trasformare il luogo-casa
Mi è capitato spesso ultimamente di riflettere su quanto la messa in discussione dei ruoli di genere ci costringa ad avere a che fare con il conflitto e le sue ambivalenze. Parlo nello specifico della gestione dell'ambiente domestico e delle complesse relazioni che vi si innestano quando al luogo-casa si sovrappone il «luogo relazionale» della coppia. Un discorso che non appare così fuori luogo rispetto a quanto si sta discutendo se inquadrato nel dato per cui l'80% dei femminicidi di quest'anno rientra nell’ambito della violenza domestica. Laddove lo sforzo verso relazioni affettive più eque si riflette nel tentativo di scardinare i tradizionali ruoli di genere e i compiti ad essi connessi può capitare di incappare in un «vuoto normativo».
Chi deve fare cosa quando non si vuole perpetuare una divisione del lavoro di cura (degli ambienti e delle relazioni) tutto scaricato sulla figura femminile o femminilizzata? A chi va il compito odioso e svalorizzante della pulizia degli ambienti, a chi quello più valorizzante della preparazione dei pasti? Come gestire il vertiginoso e impattante aumento del lavoro di cura che comporta l'arrivo di unə bambinə, o il carico mentale della pianificazione delle lavatrici o della spesa alimentare, presə come siamo da una vita precaria e vittime di una società che col ricatto economico erode sempre più gli spazi del tempo libero? Abbandonata in fretta l'illusione che un'equa ripartizione scaturisca naturalmente dai semplici ideali egualitari e dall'accordo spontaneo frutto dell'amore reciproco, ci si può trovare di fronte al precipitare costante delle tensioni quotidiane proprio nella gestione dell'ordine domestico e delle esigenze ad essa connessa. Il conflitto può allora darsi più duramente di quanto ci si aspettava e l'attrattività della convivenza – anche nell'ideale meno romantico e più politicizzato di quella di un tempo – lasciare spazio ad una realtà fatta di continue ed estenuanti negoziazioni venate da strumentalizzazioni e rinfacciamenti. Aspetti che da fuori possono apparire banali e di poco conto sono ciò che mi ha fatto constatare più da vicino la robustezza di quel ponte sopra l'abisso, di stare respirando davvero, anche io, quella tossicità nell'aria. Ho provato a ragionare allora su quel vuoto normativo e ho riconosciuto un bisogno – che è personale e non vuole qui essere una ricetta ma una mera condivisione – di nuove regole che dessero forma al personale politico della convivenza. Attribuirsi chiaramente i singoli compiti di cura della casa e delle relazioni che la abitano e discutere del carico che comportano, sperimentarli e scambiarli in un confronto schietto su cosa fanno risuonare dentro di noi. E ancora confrontarsi sinceramente rispetto alle esigenze e ai desideri personali riguardanti il lavoro, la socialità extra-domestica, lo spazio e il tempo dell'intimità o della condivisione del luogo-casa con altre persone vicine. Cominciare dalla casa, laddove si concentra maggiormente la violenza di genere, equivale a riconoscere la sua fondamentale funzione di «appaesamento» e di prefigurazione sociale, cambiandola però di segno, perché, prendendo a prestito le parole di bell hooks, «quando non si ha più lo spazio di costruirsi una casa, è impossibile costruire una vera comunità di resistenza».
Illustrazione di copertina di Thomas Maria Lindeberg
Federico Bosis ha studiato antropologia appassionandosi a temi quali la famiglia, le nuove parentele e l’abitare; cresciuto guardando dall’alto il lago di Como lavora da qualche tempo come operatore sociale a Torino, dove ha partecipato a diverse esperienze di condivisione e discussione sulla maschilità.