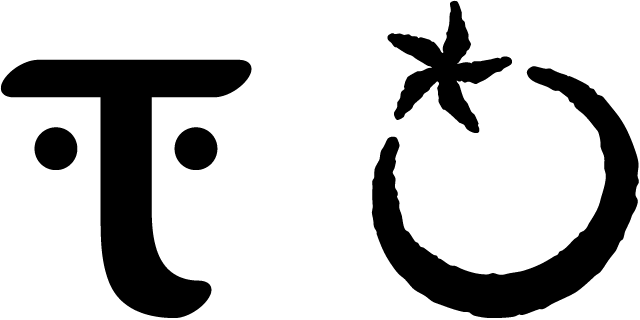Il 23 giugno 1946 la neonata Repubblica Italiana firmava il “Protocollo Italo-Belga per il trasferimento di 50.000 italiani in Belgio”. Modello per le future politiche economico-migratorie europee, l’accordo bilaterale portò oltre 300.000 italiani nel Regno belga. A 75 anni da quella data, lo scambio tra vite, corpi e salute degli emigranti provenienti dalle due sponde del Mediterraneo e il Nord dell’Europa continua a definire il sistema economico e politico-ecologico su cui si regge l’Europa.

In questo breve intervento non intendo tanto soffermarmi sulla storia migratoria italiana in Belgio. Esistono sul tema decine di libri e articolii che hanno sviscerato quasi ogni aspetto della vicenda dei circa 300mila italiani che dal 1946 presero la via del Belgio, al ritmo di 2mila a settimana, per gettare i propri corpi nelle miniere di carbone. Quello che vorrei tentare di fare è di concentrarmi sull’aspetto politico-ecologico dell’accordo e sulle implicazioni che esso ha avuto tanto sulle politiche migratorie italiane ed europee che sulla politica e sui discorsi egemonici di tipo economico e ambientale che hanno sostenuto – e ancora sostengono – il progetto unitario europeo.
Migrazioni e ricostruzione europea
Una delle poche linee di continuità che si possono tracciare a partire dall’Italia preunitaria fino al giorno d’oggi è quella relativa alla mobilità in uscita. Non sorprende dunque che il governo di unità nazionale che traghettò il paese al referendum, così come i successivi governi a guida democristiana pensassero all’emigrazione quale naturale valvola di sfogo per tenere sotto controllo il costo del lavoro e per governare meglio il processo di ricostruzione concentrandolo nel nord del paese. La famosa frase di De Gasperi «imparate una lingua e andate all’estero» rispecchia benissimo questo atteggiamento. Bisogna sottolineare che anche il Pci e la Cgl unitaria supportavano i progetti emigratori del governo. I comunisti volevano in tal modo liberarsi di alcuni ex partigiani poco fedeli alla linea e restii all’idea di abbandonare le armi e la causa rivoluzionaria, mentre la Cgl vedeva l’emigrazione soprattutto come uno strumento per salvaguardare e stabilizzare i livelli salariali. Anche il Vaticano si era mosso per riallacciare le filiere migratorie tra Italia e Americhe attraverso la propria rete diplomatica.
Dall’altro lato, il cuore industriale dell’Europa occidentale – ossia le industrie carbonifere e siderurgiche dell’Alsazia-Lorena e del Nord-Pas-de-Calais francese, la Vallonia belga, la Ruhr tedesca e i bacini industriali e carboniferi britannici, ma anche i paesi non toccati dal conflitto come la Svizzera e la Svezia – aveva un disperato bisogno di manodopera per far fronte al piano di ricostruzione europea. A differenza della grande mobilità e disponibilità di manodopera del periodo antecedente al primo conflitto mondiale, trent’anni di guerre, protezionismo e nazionalismo, unite alla morte di milioni di lavoratori nei campi di battaglia, avevano altamente ridotto la disponibilità di forza lavoro. Per ricostruire l’Europa – o meglio per rilanciare il suo apparato tecno-produttivista e socioeconomico basato sulla crescita e sull’industria pesante alimentata dal carbone – servivano braccia, e nessun paese dell’Europa nord-occidentale era disposto a rinunciare ai propri lavoratori in questa congiuntura di grande ripresa produttiva. Dopo aver provato a ingaggiare minatori francesi, inglesi, olandesi e persino a trattenere i prigionieri di guerra tedeschi, il Belgio dovette così volgere lo sguardo al Mezzogiorno d’Europa.
Il metabolismo del carbone
Il capitalismo industriale, soprattutto prima dell’avvento della terziarizzazione a partire dagli anni ’70 del ’900, si struttura alla maniera di un organismo vivente che consuma natura sotto forma di forza lavoro, risorse naturali ed energia. In Belgio, al centro di questo rapporto metabolico vi era il carbone. I lavoratori italiani impiegati nelle miniere vallone avevano il compito fondamentale di azionare questo processo metabolico nella sua fase iniziale, quella estrattiva, completata poi dalla trasformazione del carbone in carburante per gli altiforni delle acciaierie, in energia elettrica o nelle centinaia di prodotti derivati che, alla maniera del petrolio e dei suoi derivati, si ottenevano dalla lavorazione del carbone.

E il governo italiano? Fino all’indomani della catastrofe di Marcinelle, nonostante i ripetuti richiami da parte dei minatori italiani a mezzo di lettere e richieste formali trasmesse ai consolati, la Repubblica fece ben poco per i suoi emigranti. Lo scambio tra corpi e carbone era anche uno scambio tra la salute dei lavoratori e la salute dell’emergente capitalismo italiano. I lavoratori italiani con il loro sacrificio avrebbero contribuito alla crescita del paese e alla ricostruzione economica europea, formando allo stesso tempo la base sociale della nascente forza lavoro europea. Il sacrificio della loro salute era solo una delle varie esternalità che il capitalismo europeo scaricava a «costo zero» sull’ambiente, che fosse sotto forma di inquinamento industriale delle zone minerarie e industriali o dei corpi di lavoratori e lavoratrici.

Quali sono dunque le continuità/eredità di questa necropolitica migratoria ed estrattivista europea al giorno d’oggi? Le miniere belghe, così come quelle francesi, inglesi e tedesche sono ormai chiuse, ma in Polonia e nel resto dell’Europa orientale, così come in Asia e in America, il carbone è ancora un elemento fondamentale del sistema economico, ecologico ed energetico globale. Nuovi corpi continuano a essere sfruttati, consumati e sostituiti nelle miniere di litio, carbone e uranio dell’ex colonia belga, la Repubblica Democratica del Congo, così come in altri stati africani, in Cina, India, Bolivia e Brasile.
Il Belgio continua ad avere una parte importantissima in queste reti capitalistiche globali, sia in quanto centro dell’Ue che tramite fondi di investimento e grandi multinazionali come Umicore e Solvay. La Vallonia, da cuore industriale e centro propulsivo del paese, vive tra le rovine del capitalismo in un’epoca sospesa, tra passato industriale e senza un’idea di futuro, incapace di ripensare un presente diverso da quello della grande industria pesante. Il metabolismo del carbone ha consumato non solo l’ambiente, ma anche la capacità di immaginare un’alternativa alle proprie logiche distruttrici e consumatrici della vita e della natura. La stessa comunità italiana, sebbene attraverso il proprio sacrificio personale sia divenuta l’ultima custode dell’identità industriale vallona e goda di una visibilità e di una considerazione pari forse solo a quella degli italiani in Argentina, è tra le più in difficoltà del paese, con tassi di disoccupazione e abbandono scolastico simili a quelli del Sud Italia.
E l’Italia? Prima che scoppiasse la pandemia, il tasso di emigrazione nazionale aveva raggiunto i livelli della Seconda grande migrazione italiana nel primo decennio successivo al 1945, con oltre 130mila espatriati all’anno. Non serve grande lungimiranza per immaginarsi che quando verrà meno il blocco dei licenziamenti questo flusso riprenderà più forte di prima, investendo in particolare il già martoriato sud del paese e magari riorientandosi verso Germania, Svizzera, Scandinavia, Francia e forse di nuovo il Belgio, oltre al Regno Unito, con buona pace degli ultras della Brexit.
Gli oltre duecento miliardi di euro di NextGenEU, tanto celebrati dai giornali, serviranno a finanziare soprattutto opere infrastrutturali, dalla Tav alla fibra ottica, passando per il Tap, la metanizzazione e rigassificazione del paese, dighe e progetti di agricoltura intensiva, con aziende quali Eni e multiutility dell’energia, telecomunicazioni, agrobusiness e comparto meccanico-automotivo, beneficiate speciali previa un’opera di greenwashing della propria immagine. In questo piano di «razionalizzazione» e «transizione verso la sostenibilità», la parola «sostenibilità», come ha esplicitamente dichiarato sulle pagine del «Corriere della Sera» il presidente di Confindustria Bonomi, va declinata in senso lato, quindi anche e soprattutto «economico», e non solo in forme che il presidente degli industriali italiani ha definito «ideologiche», ossia relative alla sostenibilità ambientale. Sfruttamento del lavoro, dell’ambiente, e un nuovo ricorso alla valvola di sfogo emigratoria restano perni della politica italiana e della sua riorganizzazione economica. Settantacinque anni dopo il Protocollo italo-belga e l’accordo «uomini contro carbone», il nuovo programma europeo NextGenerationEU per le lavoratrici e i lavoratori italiani si delinea come un nuovo scambio tra corpi, natura ed emigrazione, che sacrificando territori in tutto il paese spingerà una nuova ondata emigratoria verso l’Europa nord-occidentale. Ça retourne…
Per approfondire
Canovi, Antonio (2011), L’immagine degli italiani in Belgio. Appunti geostorici, “Diacronie. Studi di storia contemporanea”, n. 5, pp. 1-16.
Colucci, Michele (2008), Lavoro in Movimento. L’emigrazione italiana in Europa 1945-1957, Roma, Donzelli.
Cumoli, Flavia (2009), Dai campi al sottosuolo. Reclutamento e strategie di adattamento al lavoro dei minatori italiani in Belgio, “Storicamente” 5, n° 6, DOI: 10.1473/stor290.
De Clementi, Andreina (2010), Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra, Roma-Bari, Laterza.
Di Stefano, Paolo (2011), La catastròfa. Marcinelle 8 Agosto 1956, Palermo, Sellerio.
Morelli, Anne (1988), L’appel à la main-d’oeuvre italienne pour les charbonnages et sa prise en charge à son arrivée en Belgique dans l’immediatd après-guerre, “Revue belge d’histoire contemporaine”, n. 2, pp. 83-130.
Ricciardi, Toni (2016), Marcinelle 1956. Quando la vita valeva meno del carbone, Roma, Donzelli.
Valisena, Daniele (2020), Coal Lives. Italians and the Metabolism of Coal in Wallonia, Belgium 1945-1980, Tesi di dottorato, Stoccolma, KTH Royal Institute of Technology.
Daniele Valisena si occupa di migrazioni, ambiente e memoria. Ricercatore universitario e giornalista, ha lavorato nella sua Emilia, in Francia, Germania, Svezia e Belgio ed è parte del laboratorio Ecologie politiche del presente, con base a Napoli.