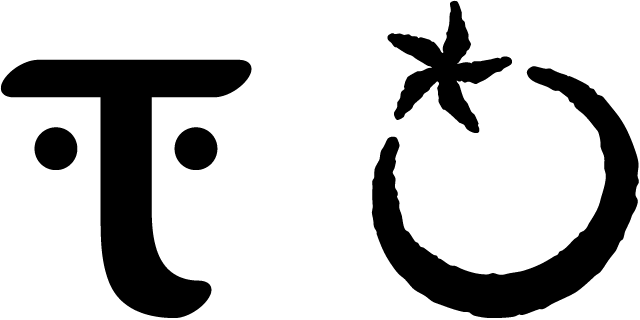Le vite di Maryam e Fareeda in Spagna
In una calda giornata andalusa, Maryam e Fareeda, madre e figlia marocchine, condividono le sfide della loro integrazione in Spagna. Maryam, donna attiva, rivela il suo adattamento al nuovo paese, mentre Fareeda lotta per ottenere la cittadinanza: le loro storie esplorano le dinamiche di genere nella migrazione suggerendo la creazione di spazi inclusivi che permettano alle donne di superare stereotipi e discriminazioni e riconoscere la complessità delle identità nel contesto migratorio.
Mentre aspettavamo il tè in un bar, in una delle tipiche pause prolungate alla spagnola, Maryam stava ricordando i miei primi giorni di lavoro in associazione. Fareeda, sua figlia, se la rideva. Maryam è una signora di cinquantadue anni, originaria di Tétouan in Marocco, dalla personalità effervescente e caratterizzata da una pungente schiettezza:
«Stavo camminando verso l’associazione, c’era la gente in fila fino in fondo alla via. Sono entrata e ti ho vista...stavi facendo un po’ di casino! non scorderò mai la tua faccia. (ride) ti ricordi? Mi sono avvicinata e ti ho aiutata a compilare la richiesta per quel signore».
Era il quarto giorno di lavoro, non avevo ancora preso dimestichezza con tutto l’apparato burocratico dell’associazione, la mia tutor era malata e io ero da sola in acojida (accoglienza). Quella non fu l’unica giornata frenetica dedicata all’accoglienza, ma di sicuro fu una delle giornate che segnarono il mio settembre del 2021. In quel periodo avevo iniziato a lavorare come tirocinante in una Ong spagnola per l’integrazione dei migranti. Avevo scelto la Spagna, in particolare l’Andalusia, perché da studiosa di questioni di genere e migrazioni sapevo essere una zona molto calda: gli arrivi di persone dal Nord Africa, specialmente dal Marocco, sono all’ordine del giorno. Stavo scrivendo la mia tesi magistrale e volevo raccogliere storie di migranti, volevo sentire le loro voci.
Lavorare nell’accoglienza mi aveva permesso di conoscere gli assidui e i consuetudinari dell’associazione, imparando a tessere fitte relazioni con loro, non solo al mero scopo della ricerca ma instaurando autentiche amicizie. Maryam, ad esempio, era un’utente abituale: lì aveva svolto tutte le pratiche per ottenere la cittadinanza e continuava a venire talvolta per fare qualche corso di cucina, talvolta per aiutare come traduttrice. Aveva cresciuto Fareeda, che stava studiando per diventare assistente sociale, in Spagna. Come me, sua figlia era tirocinante nell’associazione.
Il tè arrivò in una tazza fumante. Certo, con la calura andalusa – il termometro segnava 35 gradi – mi sembrava un azzardo, ma Maryam insisteva sulle proprietà dissetanti della bevanda. Mentre soffiavo sulla tazza bollente chiesi a Maryam come mai aveva scelto di migrare proprio in Spagna. La donna sapeva che volevo conoscere la sua storia ed era entusiasta all’idea di raccontarsi. «Colpa di suo padre»! rispose ridacchiando e accennando verso Fareeda. Il marito di Maryam era un artigiano, negli anni ’90 spesso commerciava in Spagna e durante uno dei suoi viaggi ci restò illegalmente. Ci mise dieci lunghi anni per ottenere la cittadinanza e solo in seguito riuscì ad ottenere il ricongiungimento familiare e finalmente vivere sotto lo stesso tetto con la moglie e la figlia, in Andalusia.
«Ho iniziato subito a lavorare lavando le scale dei condomini, le case dei vicini, i negozi nelle chiusure, prendendomi cura degli anziani del quartiere, portandoli a fare qualche passeggiata o lavarli»…
Come Maryam, molte donne immigrate iniziano a lavorare nel paese ospitante come collaboratrici domestiche o impiegate nei servizi assistenziali di cura. Negli anni ’70, con lo spostamento della produzione industriale in regioni a basso salario, le donne occidentali hanno visto aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro. Ciò ha imposto loro la sfida di bilanciare il lavoro retribuito con le responsabilità familiari. Contestualmente, gli stati occidentali, adottando politiche neoliberali, hanno ridotto le risorse destinate al welfare, affidando la gestione di servizi essenziali a enti privati. Il lavoro di cura, quindi, è stato trasferito alla sfera privata, creando una domanda di servizi a buon mercato soddisfatta dalle «catene di cura transnazionali» che reclutano soprattutto donne povere, migranti e soggetti razzializzati. Queste dinamiche segnano ciò che potremmo definire come la «crisi della cura» non più intesa come motore di riproduzione del mondo, ma come veicolo di disuguaglianze. Mentre le disuguaglianze decretano chi, come, quanto e dove una persona ha diritto di essere curata, le assistenti familiari devono far fronte a una serie di condizioni sociali come quella di essere straniera. Maryam,infatti, lavora sodo ma con una paura, quella di poter essere scambiata per una straniera fannullona:
«Mi sono data da fare, lavoravo di notte, seguivo le mie figlie nei compiti, ero rappresentante di classe, facevo corsi di spagnolo (…) Sai, dopo la morte di mio marito, non volevo che pensassero che stessi qui a non fare nulla».
Per molte donne, come per Maryam, migrare in un nuovo paese e iniziare a lavorare contribuisce a creare nuove traiettorie di vita come, per esempio, diventare «capi famiglia». Maryam diventa breadwinner ribaltando e invertendo i modelli e le aspettative di genere, emancipandosi dal tipico ruolo che, forse, l’avrebbe intrappolata in quello di madre e moglie. Il fenomeno della migrazione rappresenta un intricato intreccio di esperienze, influenze culturali e dinamiche di genere che plasmano e vengono plasmate dai flussi migratori. Il genere agisce come forza guida nei processi migratori, determinando chi decide di migrare, le ragioni dietro tale scelta e le modalità con cui avviene il trasferimento. Al contempo, l'esperienza stessa della migrazione è intrinsecamente connessa a spinte di denaturalizzazione e risignificazione delle pratiche femminili. Il dibattito attuale si concentra sul valore della migrazione e dei suoi effetti, quali il condurre a una maggiore libertà o reclusione e il favorire il cambiamento o il consolidarsi di dinamiche sociali preesistenti. Tuttavia, anziché cercare risposte definitive a tali interrogativi, dovremmo focalizzarci sugli spazi di trasformazione intrinseci alle migrazioni stesse. L'obiettivo dovrebbe essere la creazione di nuovi percorsi e alternative che consentano una visione più ampia e sfaccettata di questo fenomeno complesso.. Inoltre, è fondamentale evitare il pregiudizio legato a una visione orientalista che contrappone l'Occidente civilizzato all'Oriente retrogrado. La decostruzione della partizione binaria genere/sesso trova terreno fertile nel paese di arrivo, grazie alle influenze della deterritorializzazione e deculturalizzazione delle tradizioni del paese di origine. Valori, stili di vita, usi, costumi e credenze differenti appartenenti ai due mondi tra cui la migrante è sospesa si amalgamano determinando sia la somma dei vincoli simbolici e relazionali, sia l’opportunità di trasformare e ridefinire le categorie di genere. Tuttavia, approdare in Europa non implica automaticamente una rottura con la naturalizzazione del genere, alimentando l'idea dell'Occidente come unica fonte di emancipazione. Al contrario, si assiste inevitabilmente a una transizione verso un sistema diverso di espressione del patriarcato. L’Europa, pur offrendo nuove prospettive, presenta ancora sfide legate alle dinamiche di genere, evidenziando la complessità del processo di trasformazione all'interno delle migrazioni. La relazione tra genere e migrazione è intricata e sfaccettata, influenzata da una miriade di fattori culturali, sociali ed economici. La migrazione può essere un catalizzatore per la decostruzione delle norme di genere, offrendo spazi per la creazione di nuove identità e significati. Tuttavia, è cruciale evitare semplificazioni e stereotipi, riconoscendo che il processo di emancipazione non è automatico e che le sfide legate al genere persistono anche in nuovi contesti migratori.
Un’ulteriore sfida è legata all’ottenimento della cittadinanza. Eppure Maryam sembrava in disaccordo e, sorseggiando il suo tè nero, tentò di rassicurarmi sull’argomento:
«Ottenere la cittadinanza non è un dramma, basta che porti cinque persone che garantiscano per te». Mi raccontò di un iter burocratico lungo e lento, ma, a suo dire, doveroso: «Se ti comporti nella maniera giusta con le persone del posto non avrai alcun problema con le pratiche».
Mi alzai per pagare. Maryam ci salutò (una vicina l’aveva chiamata per fare qualche ora di pulizie). Fareeda tirandomi per il gomito mi avvicinò a sé:
«Non so come faccia a dirlo, ottenere la cittadinanza è orribile»! La ragazza mi spiegò che più che dimostrare di essere cittadina bisogna dimostrare di meritarsi la cittadinanza.
Il concetto di cittadinanza moderna, in Europa, solleva una serie di interrogativi cruciali riguardo a chi sia considerato meritevole di diventare, in questo caso, spagnolo, e, più in generale, di essere riconosciuto come cittadino. L’identità degli stranieri, secondo il paradigma occidentale, si forma attraverso una negazione, un essere altro privo di specifiche pratiche giuridiche, politiche, economiche e culturali caratteristiche di una determinata collettività. Questo individuo è percepito come lacunoso, difettoso e fragile, costringendolo a costanti rimostranze e valutazioni per conformarsi agli standard della comunità ospitante. Tale percezione è particolarmente evidente quando si considera la posizione delle donne, storicamente designate come soggetti deboli e cittadine passive a causa dei tradizionali ruoli riproduttivi e di cura che le relegano alla sfera domestica La casa e la sfera privata sono spesso considerate come luoghi apolitici in cui non c’è spazio per la cittadinanza attiva. Una donna straniera, specialmente se impiegata nel settore della cura e non inserita nel mercato del lavoro, appartenente a una minoranza culturale e con un livello di istruzione limitato, viene spesso esclusa dal riconoscimento pieno di cittadinanza. Tuttavia, questo giudizio non tiene conto delle pratiche di partecipazione attiva che molte donne migranti mettono in atto, spesso attraverso associazioni da loro stesse create.Queste spesso nascono a partire da un determinatore comune: la condizione di essere insieme donne, straniere, immigrate o emarginate. La posizione identitaria che occupano queste donne è intersezionale.
Stavamo rientrando verso l’associazione. Camminavamo a ritmo lento. Percepii la necessità di raccontarsi della ragazza, così le chiesi di fare il giro più lungo e guadagnare qualche minuto per noi. Nel frattempo, Fareeda continuava il suo sfogo descrivendomi l’iter per l’ottenimento della cittadinanza a cui si era dovuta sottoporre. Dopo svariati esami di cultura generale e diverifica delle conoscenze grammaticali e lessicali della lingua arriva l’ultimo step: il colloquio. Fareeda cominciò a ricordare con disagio di aver dovuto portare la testimonianza di cinque persone che la descrivessero come una buona cittadina, rispettosa della comunità e integrata.
«Per me è stato umiliante, perché la parola di uno spagnolo dovrebbe valere più della mia»? Mi raccontò di quanto fossero personali le domande degli esaminatori, di aver pensato di boicottare l’intero esame, ma allo stesso tempo, le ritornavano alla mente tutte le storie degli amici e dei parenti respinti dallo stato spagnolo. Sua madre le aveva narrato queste vicende, supplicandola di comportarsi correttamente e rispondere: «Quanti amici hai? Quante volte a settimana li vedi? Hai foto con loro? Hai mai avuto un fidanzato spagnolo? Che rapporto hai con i tuoi vicini di casa»?
La ragazza si fece più seria in viso. «Mi ha sempre creato molta sofferenza capire chi fossi, identificarmi in qualcosa, in qualcuno»… Fareeda incarna il concetto di essere una figlia dell'immigrazione. Tale definizione mira a evidenziare la sua capacità di agire, discostandosi dalla concezione passiva spesso attribuita ai figli degli immigrati, considerati segnati in modo indelebile dal marchio del migrante, trasferito quasi come un testimone da genitori a figli. Questa identificazione ha rappresentato per molti anni una trappola per Fareeda. Il suo vissuto si sviluppa in una zona interstiziale, un confine-sconfinamento tra Oriente e Occidente, Marocco e Spagna, Islam e Cristianesimo. In questa realtà, le regole marocchine governano la vita domestica, mentre quelle spagnole influenzano il mondo esterno. Questo scenario genera in Fareeda un senso di instabilità, una sfida nel definire la propria identità. La giovane si interroga, confusa: "Non capivo più chi fossi, ero marocchina o ero spagnola?" La sua esperienza incarna la complessità e le sfide di chi vive al crocevia di culture e identità diverse.
Fareeda testimonia il senso di smarrimento, la sensazione di essere schiacciata tra due culture, tra due paesi, tra due religioni, la frustrazione del non appartenere, il vuoto del non riconoscersi e non essere riconosciuta né come pienamente marocchina, né come totalmente spagnola. «Se mi comportavo come gli spagnoli, tornavo a casa e mio padre mi sgridava , se mi comportavo come i marocchini, gli spagnoli mi prendevano in giro e mi emarginavano». Per la giovane figlia dell'immigrazione, l'identificazione e la costruzione della propria soggettività si sono rivelate un’autentica opera di contrattazione. Il processo è stato il risultato di una negoziazione costante tra due realtà distintive: quella all'interno delle mura domestiche e quella al di fuori.È così che Fareeda mi spiegava le sue battaglie di emancipazione: se il padre non voleva portasse abiti attillati o maniche corte, ecco che la ragazza perseverava nel metterle: «Mio padre mi inseguiva e mi dava due schiaffi, sperava smettessi. Alla fine, si è stufato di picchiarmi, mi voleva bene». Se gli scontri in famiglia sembrano essere più fisici, quelli fuori casa sembrano ferirla nell’animo e tormentarla psicologicamente: «Puoi fare sesso o ti rinchiudono? Non è che fai parte di qualche gruppo terrorista? Quando fai il ramadan puoi mangiare le gomme? Se fai queste domande senza capire quanto sei invadente allora sei inappropriato, non ti rispondo»!
Eravamo ormai vicine all’entrata dell’associazione, la pausa tè si era un po’ dilungata. Non sembrava importarcene molto. Mi affacciai nella sala d’attesa, sembrava una giornata tranquilla. Ci prendemmo altri cinque minuti.
«Quando ho capito che io potevo essere quello che volevo, mi sono sentita bene. Se mi fosse piaciuto questo aspetto delle usanze spagnole sarebbe diventato mio, se mi fosse piaciuto quell’altro aspetto della vita musulmana l’avrei osservato». Reinterpretare le proprie origini, rivisitando tradizioni, esperienze familiari e comunitarie oltre a risignificare i valori culturali in modo inedito e dinamico, permette a chi vive una situazione simile a quella di Fareeda di attivare strategie di soggettivazione che riconoscono la diversità come un valore aggiunto e elemento di estrema qualificazione identificativa. Fareeda racconta come la sua identità sia il risultato di un’operazione di taglia e cuci sistematico tra le due culture. La zona di confine-sconfinamento che abita sembra non costituire più un impedimento alla costruzione della propria soggettività, ma, al contrario, sembra rappresentare un’opportunità di scelta, l’occasione di decidere chi essere. «Sai, attraverso studi all’università di antropologia, sociologia, mi sono accorta che era molto importante l’identificazione in sé stessi, devi accettare te stesso prima che la società ti accetti».
La figlia dell’immigrazione sembra aver trovato un suo equilibrio: la sua storia sembra avere un lieto fine, ovvero, quello del raggiungimento e riconoscimento della propria identità. Tuttavia, cosa succede a coloro che non hanno studiato sociologia o antropologia? A chi non ha mai collaborato con un’associazione? O ancora, a chi mancano gli strumenti per prendere consapevolezza di sé stesso? E per coloro che non hanno avuto le stesse opportunità di trasformazione di Fareeda? I percorsi migratori sono eterogenei, e le persone li percorrono in modi diversi; è per questo che è cruciale creare costantemente nuovi spazi di trasformazione per generare opportunità inedite per coloro che si impegnano in tali percorsi. L’intersezionalità si presenta come il motore del cambiamento, riconoscendo la complessità delle identità e dei percorsi individuali all'interno del contesto migratorio.
Fareeda con un sorriso continuava a ripetermi: «Devi accettarti»!, si sistemò i capelli incastrandoli sotto il velo con una forcina ed entrò in associazione.
Lucrezia Alice Moschetta è laureata in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, specializzandosi in lingua russa e spagnola. Successivamente ha conseguito una laurea magistrale nella medesima università in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità. Attualmente è una ricercatrice dell’Università di Padova e lavora sul progetto nazionale https://www.ageit.it. Si occupa di Invecchiamento, Cura, studi di Genere, Intersezionalità e studi Decoloniali.