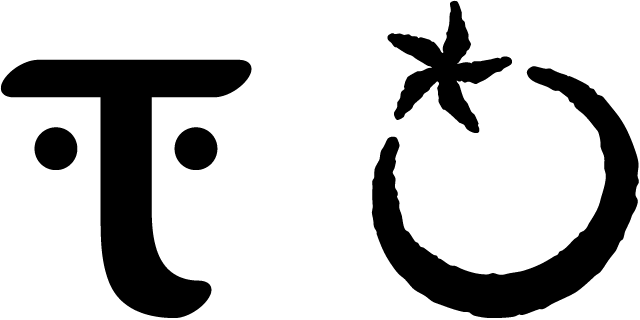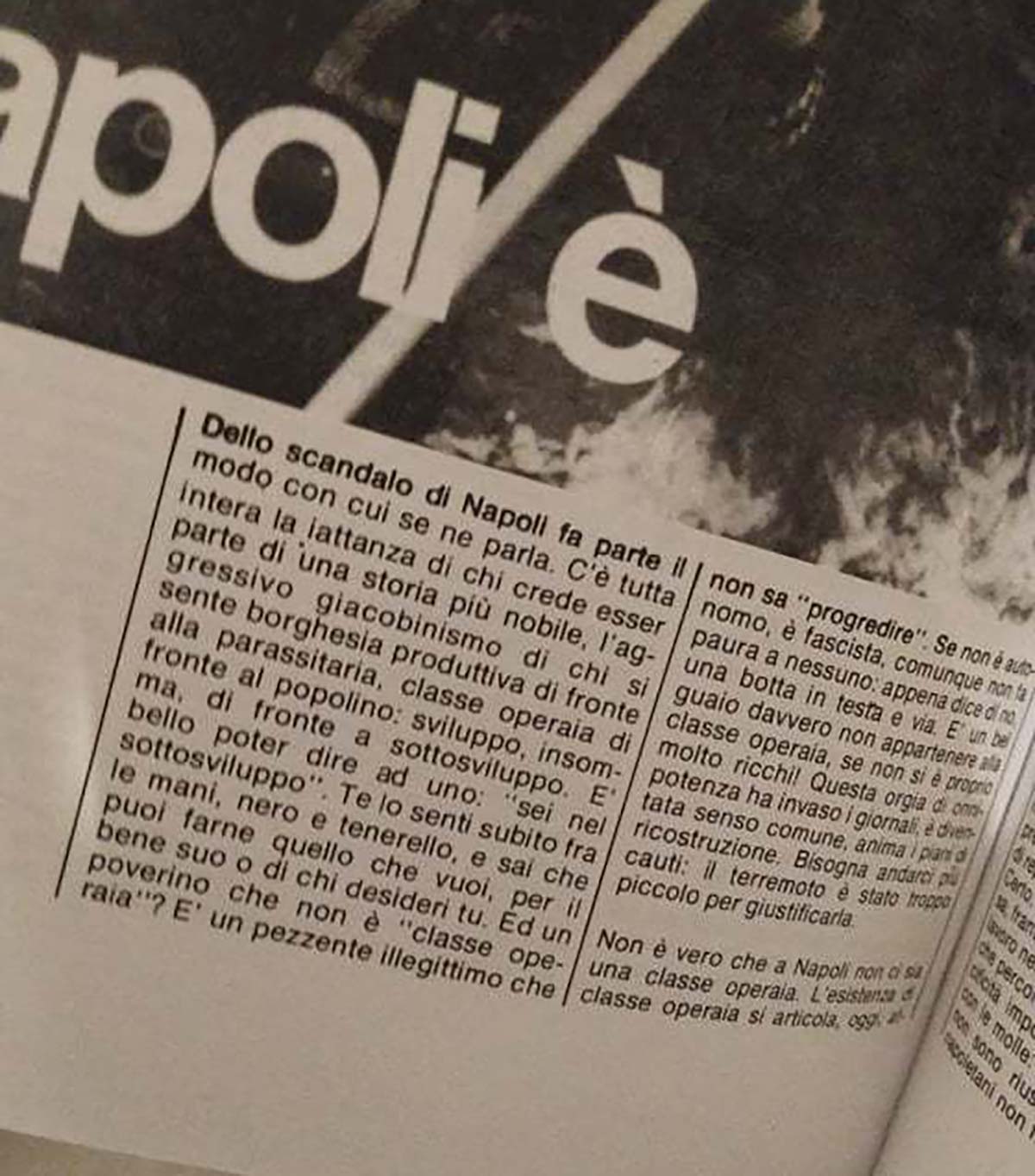Violenze poliziesche, razzismo e Questione meridionale
È ancora più complicato ritrovarsi a farlo da Napoli, una città che, per certi versi, esemplifica al meglio questa complessità che non vuole essere risolta in schemi elaborati altrove e in linguaggi altrui.
Vivo a Napoli da pochi mesi: in questi pochi mesi, sono già morti due ragazzi adolescenti, entrambi ammazzati dalle forze dell'ordine, entrambi in situazioni di (presunta) illegalità – Ugo Russo, la notte del 1° marzo, e Luigi Caiafa nella notte tra sabato e domenica scorsi.
Non ho competenze – né esperienza di pratiche e vissuti – per esprimermi sulle dinamiche territoriali, politiche e sociali di questa città e delle sue diverse dimensioni; però da un po' di tempo accompagno i dibattiti dei movimenti antirazzisti e credo che, oggi, queste vicende ci mostrino la necessità di provare a riflettere su come i discorsi razziali si declinino all'interno dell'identità nazionale italiana e, in particolare, si articolino dentro a/con la Questione meridionale.
Quest'anno ci è capitato di parlare tanto sia di abusi di polizia che di razzismo strutturale, a seguito dell'assassinio di George Floyd e di una nuova fase espansiva del movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti. In Italia, abbiamo guardato tuttx con entusiasmo ed interesse a questo movimento e soprattutto alle sue pratiche radicali; ma, al tempo stesso, credo che abbiamo sperimentato delle enormi difficoltà a capire come e se riportare qui il dibattito statunitense. Ci siamo trovatx schiacciati tra due constatazioni: da una parte, la sensazione che si trattasse di un entusiasmo "per conto terzi", che portava in Italia una specie di passerella antirazzista che non avrebbe messo realmente in discussione il razzismo strutturale nostrano e l’eredità coloniale dello stato italiano; dall’altra, le posizioni – ormai insostenibili eppure portatrici di tanta fortuna – di quanti, anche dentro i movimenti della sinistra italiana, ritengono semplicemente "non abbastanza radicali" le lotte che si concentrano sulle questioni di razza (e/o genere), invece che di classe – posizioni che partono proprio dalla sbagliata concezione di questi elementi come separabili invece che indissolubilmente articolati insieme. In questo dibattito, con buone intenzioni e alla ricerca di una traducibilità immediata, è emersa anche l’intenzione di tantx attivisti e militanti che hanno ritenuto più opportuno concentrarsi sulle violenze poliziesche che hanno avuto luogo in Italia, sintetizzando la questione in slogan come "Anche noi abbiamo i nostri George Floyd: sono Cucchi, Aldrovandi, Magherini". Qui è necessaria una precisazione: appartengo ad una generazione che ha fatto degli abusi in divisa una battaglia identificativa, poiché, cresciuti dopo Genova e nei movimenti del 2008, abbiamo imparato ad empatizzare facilmente con i nostri coetanei vittime delle violenze poliziesche. La considero una delle lotte umanamente e politicamente più importanti in cui mi riconosco. Tuttavia, come è stato scritto in questo caso da varx attivisti non-bianchx, il problema è che la violenza di polizia non è uguale dappertutto né su tutti i corpi, e che questa “traduzione” aveva l’effetto collaterale di cancellare l'elemento fondamentale delle proteste di BLM: quello del razzismo strutturale.
Effettivamente, i meccanismi di profilazione razziale con cui agiscono l'intero sistema americano e le sue propaggini repressive sono qualcosa che ci è difficile comprendere e "tradurre", perché molto specifici e peculiari: hanno a che fare con la trasformazione automatica di un determinato soggetto – nero, tendenzialmente maschio, con un determinato dress-code e, eventualmente, con in mano qualsiasi cosa che possa essere scambiata per un arma – in un bersaglio mobile a cui è legittimo e doveroso sparare.
Non abbiamo una equivalente conoscenza – non a livello diffuso, per lo meno – di quali siano i meccanismi specifici con cui la violenza poliziesca si esercita, in Italia, sui corpi non-bianchi: probabilmente, su soggetti considerati clandestini e irregolari, che spariscono negli angoli bui della legge, nelle caserme, nei Cpr (ex Cie) e nelle questure, senza che nessunx abbia nemmeno modo di rivendicare la loro storia e senza che possano entrare direttamente nelle battaglie dei movimenti contro gli abusi.
Eppure, in Italia succede anche un'altra cosa: anche in questi movimenti “antipolizieschi”, quando ci troviamo a ripetere con dolore l'elenco dei "nostri" morti – non c’è altro modo per definire i Cucchi, Aldrovandi, Magherini eccetera – ci viene poco spontaneo aggiungere all'elenco anche il nome di Davide Bifolco. Quando ci viene ricordato, ci viene in mente: sì, certo, fa parte della lista, però è anche una cosa diversa. È vero, è proprio anche un'altra cosa. Innanzi tutto, dal punto di vista del processo di identificazione di cui parlavamo prima: la nostra – la mia – capacità di identificarci con un diciottenne che incontra una pattuglia insensatamente violenta tornando da una festa di notte è mediamente molto maggiore di quella di identificarci con un adolescente del Rione Traiano che non si ferma ad un posto di blocco in cui si cerca un latitante. Ancora meno, con un adolescente che – forse – fa una rapina, come nel caso di Ugo Russo.

Nel 1981, sulle pagine di Metropoli, Paolo Virno scriveva che “dello scandalo di Napoli fa parte il modo in cui se ne parla”. Il modo in cui si parla delle morti di ragazzi delle periferie di Napoli è parte integrante dello scandalo di queste morti e ne è causa. La morte di Davide Bifolco si portò dietro un dibattito enorme e agghiacciante sul piano nazionale: guarda caso, fu uno dei primi “exploit” di Matteo Salvini, che inaugurava un’epoca in cui il suo stile di comunicazione aggressivo e esplicitamente razzista sarebbe diventato egemonico; un dibattito paradossale nel quale proprio noi, non i più appassionatx degli stati-nazione in generale e dello stato italiano in particolare, ci ritrovammo a dover ricordare ai sinceri democratici quanto fosse inconciliabile con il patto sociale fondare l'ordine pubblico sulle esecuzioni sommarie. A distanza di qualche anno, la morte di Ugo Russo è stata rapidamente liquidata come una morte meritata e voluta, quasi acclamata dall’opinione pubblica di un paese in cui chi vive un’oppressione strutturale e fa una brutta fine – come le donne stuprate, i migranti nel Mediterraneo o gli operai costretti a lavorare in piena pandemia – per definizione, se l’è cercata.

Assistiamo ad una tendenza chiara: quella della progressiva normalizzazione di queste morti o, in altre parole, l'affermazione dell'idea che queste vite non valgano niente/valgano molto meno.
Il dibattito sul caso di Colleferro – a tratti molto scoraggiante – ci ha forzati ad interrogarci sull’applicabilità di concetti come quello di violenza razziale e strutturale, con risposte anche non scontate. Se non sempre la motivazione razziale è lo stimolo esplicito ed immediato di una azione violenta, credo che dobbiamo anche fare i conti con il fatto che non possa esistere, in un paese sessista, razzista, classista come l'Italia, una violenza colorblind o genderblind eccetera. Non credo, cioè, che possa esistere un esercizio strutturale della violenza che avvenga a prescindere dalle posizioni di potere di chi la esercita e di chi la subisce; non esiste esercizio di violenza che prescinda dalla percezione del valore inferiore – per ragioni di razza, genere, classe, provenienza, ecc. – della vita di chi ne è oggetto.
Il privilegio dell'esercizio della forza corrisponde alla possibilità di valutare immediatamente la storia dell'altrx e il modo in cui sarà percepita e raccontata e la conseguente impunità che ci può essere garantita. Una impunità che non è solo giuridica – come sempre succede nelle violenze di polizia – ma una impunità che, nei casi dei ragazzi di Napoli, si è fatta in questi anni anche sociale e culturale; se nella cornice nazionale le importantissime battaglie delle famiglie delle vittime nei casi più noti sono riuscite, negli ultimi anni, a cambiare almeno in parte il senso comune su questi abusi polizieschi, per i ragazzi di Napoli uccisi dalla polizia è successa la cosa opposta: ammazzarli non significa più niente oppure è cosa gradita.
Quanto conta (e conterà) tutto questo in questo momento storico in cui le strade – soprattutto quelle di Napoli, viste le misure di sicurezza anti-Covid e il trionfo elettorale di governatori-sceriffo – tornano a svuotarsi di persone e riempiersi di forze dell'ordine, sempre più legittimate all’uso delle armi?
La costruzione culturale di vite che valgono così tanto meno da diventare oggetto di una violenza strutturale giustificata e celebrata non potrebbe essere, tutto sommato, considerata una forma italiana di profilazione razziale della violenza poliziesca?
Forse questo ragionamento importa poco per chi agisce quotidianamente nella pratica su questi territori; credo però che potrebbe essere importante iniziarne a discutere in altri luoghi, ovvero nei dibattiti sul razzismo in Italia e nei movimenti antirazzisti. Non perché sia possibile fare un’equivalenza tra la violenza sui corpi meridionali e quella sui corpi afroamericani - né tra le esistenze di chi, con tutte le difficoltà, vive nel Sud Italia da cittadino italiano, e/o da persona bianca, e quelle di chi non vive una o nessuna di queste due condizioni di maggiore garanzia (anche perché ci sembra sempre opportuno smontare la fissità di queste categorie, che spesso ci portano ad identificare l’essere cittadini italiani con l’essere bianchi e persino l’essere meridionali con l’essere necessariamente bianchi). Ma per calare i nostri discorsi e le nostre analisi – e gli strumenti necessari che ci vengono dalla teoria antirazzista e postcoloniale – nelle specificità e nelle contraddizioni in cui viviamo, in un paese in cui essere bianchx significa ancora tantissimo ma in cui si è anche bianchx e non propriamente bianchx in tanti modi diversi. Guardando a Sud e al Meridione, la radicalità delle teorie e delle lotte antirazziste è sempre stata una necessità autoevidente, molto più che una scelta strategica o modaiola. Per alcunx – tantx – di noi tutto questo fa ancora la differenza tra vita e morte, e dello scandalo di queste morti fa proprio parte il modo in cui se ne parla.
Carla Panico è una storica contemporaneista, dottoranda in Postcolonialismo e cittadinanza globale al Centro Estudos Sociais dell'Università di Coimbra (Portogallo).