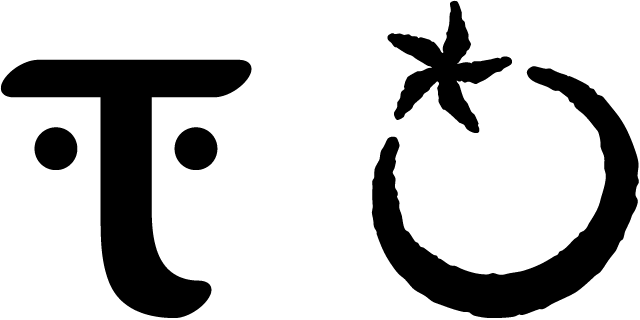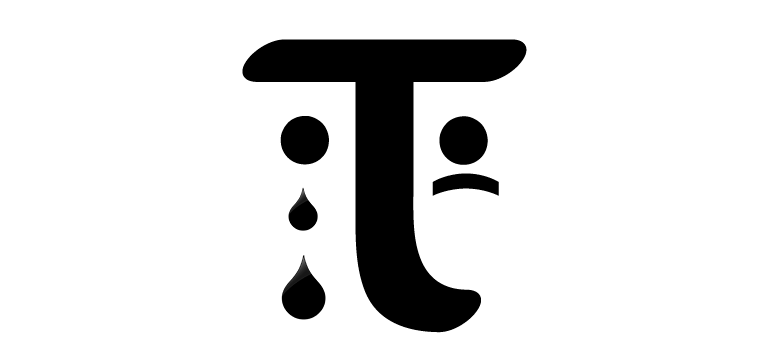La difesa dell'uso del maschile come norma linguistica è anche una difesa di un certo status sociale? Una conversazione sulla lingua, il potere e l'istruzione oggi in Italia
Con un’analisi puntuale di tutte le obiezioni sollevate a motivare il rifiuto verso i femminili professionali – un rifiuto ampiamente diffuso – Vera Gheno non solo smaschera le basi patriarcali di queste convinzioni, ma compie un’utilissima descrizione del funzionamento della lingua italiana (e non solo), rendendo accessibili nozioni che di solito sono introdotte nei percorsi di formazione solo all’università.
Decido di scrivere alla studiosa una mail per approfondire un punto che, penso, possa restare a volte in secondo piano in un lavoro che si presenta come dedicato principalmente al genere. Quello che mi interessa è capire come la difesa della norma linguistica del maschile si combini con la difesa dello status sociale (del privilegio di classe, per dirla difficile) di chi parla.
Ne viene fuori un’intervista in cui non si parla solo di questo, ma soprattutto di educazione all’uso della lingua, dell’importanza della divulgazione e dell’umiltà da tenere per imparare. Molto di più di quanto sperassi. Fabiano Mari
Partiamo dall'osservazione da cui ho preso l'iniziativa di scriverti, ribadita più volte in Femminili singolari: il fatto che la lingua italiana sembri ammettere con facilità i termini operaia e infermiera, mentre ci si scontra con la difficoltà da parte di un sistema politico-culturale di accettare la circolazione di femminili professionali come ministra, sindaca, e così via. Tu ne trai, a mio avviso opportunamente, la conclusione che in questa discrepanza si nasconda l'utilizzo in senso sessista e classista della lingua. Puoi soffermarti su come sei giunta a questa costatazione? C'è stato un momento in cui ti sei resa conto che il discorso sui femminili professionali non riguarda allo stesso modo tutti i mestieri?
A dire il vero, penso che la lingua, con queste discrepanze, riproduca le differenze presenti nella nostra società: i problemi di uso dei femminili sono legati a mestieri nei quali la presenza femminile, fino a tempi recentissimi, era nulla o scarsissima. Quindi, che bisogno ci sarebbe stato di conoscere e usare quei nomina agentis al femminile? Occhio non vede… lingua non nomina. Ed è assolutamente vero che questo discorso è particolarmente evidente per ruoli apicali (ministra, assessora, questora, avvocata), anche se le stesse difficoltà si riscontrano per i gradi militari, altro ambiente prettamente maschile (per esempio capitana) o per lavori decisamente “maschili” (minatrice, pompiera). Vorrei sfatare l’idea che la lingua sia sessista di per sé; è che, riproducendo certi schemi socio-culturali, fa da cartina di tornasole di disparità ancora presenti nella nostra società.
Ritengo che, fuori dal contesto dei linguisti, queste riflessioni siano ancora a uno stadio iniziale. Penso per esempio al fatto che poche grammatiche scolastiche hanno preso atto dell’esistenza dell’italiano neostandard, che di fatto è un italiano parlato, tutto sommato corretto, pur non corrispondendo alla norma alla quale siamo abituati dalla scuola. Quindi si insiste a insegnare un canone scolastico, che per molti versi richiama ancora quello bembiano del Cinquecento, che poi è assai raro nell’uso reale: una sorta di italiano laboratoriale che non corrisponde a quello che poi uno sente fuori dal laboratorio-scuola. E questo, inevitabilmente, crea disagio nelle persone. Ritengo che anche a scuola bisognerebbe riflettere molto di più su questo aspetto, squisitamente sociolinguistico, della conoscenza della propria lingua.
Per assurdo (ma mica tanto per assurdo), nei testi per l’insegnamento dell’italiano a stranieri si tiene quasi più conto dell’uso che non in quelli per madrelingua, dato che si presume che a uno straniero serva una lingua “consumabile”; lo stesso ragionamento non si fa (o non si fa spesso) per i madrelingua, ai quali si insegna ancora la “lingua dell’egli”, senza nemmeno accennare al fatto che nell’italiano colloquiale è del tutto normale oggi usare lui in posizione soggetto.
Beh, ma questo è normale, vista la storia dell’italiano. Siamo italofoni da pochissimo, da una sessantina di anni. Per cui è ovvio che fino a tempi recenti abbia prevalso la norma scritta: l’italiano parlato manco esisteva! Comunque, Tullio De Mauro, nei suoi scritti sull’educazione linguistica democratica, nota spesso che il tipo di insegnamento linguistico “tradizionale” serve anche – e soprattutto – per perpetuare il potere, per mantenere la piramide sociale stabile e non permettere troppi rimescolamenti tra l’alto e il basso, o meglio, per regolare in maniera rigida l’ingresso nelle élite. Scrive De Mauro in un saggio del 1975: “Se noi crediamo che vada mantenuta la divisione dei cittadini in classi diverse, cioè diversamente capaci di trarre profitto dalla partecipazione alla gestione della vita collettiva, se noi intendiamo conservare strutture e forme delle società classiste, la riduzione dell’educazione linguistica ad addestramento monolinguistico è la via migliore. È una via convalidata da secoli di esperienza in tante società diverse”. Ovviamente, lui scrive questo per criticare tale modus operandi.
Io la questione di genere e linguaggio non la sento affatto “più scritta” che parlata. Perché il problema si pone spesso nell’appellare una persona, oppure una moltitudine mista, che ho di fronte; nello scritto, avendo più tempo per la pianificazione del testo, posso quasi sempre trovare delle circonlocuzioni che mi permettono di aggirare il problema (per esempio, usando “persone” o altre parole semanticamente neutre). Proprio dall’osservazione di alcunə attivistə intervenutə alle mie conferenze rispetto all’impronunciabilità dell’asterisco (“car* tutt*”) è nata la mia proposta, assolutamente scherzosa, di usare lo schwa (come ho appena fatto). Solo dopo ho scoperto che c’è chi ha già proposto di usarlo sistematicamente per “scavalcare” il problema dei due generi grammaticali maschile e femminile (una posizione molto più estrema della mia).
Lo schwa, che è un simbolo dell’alfabeto fonetico internazionale, indica la vocale media, indistinta, che si trova nel mezzo del quadrilatero vocalico. In sostanza, è un suono indistinto per pronunciare il quale non occorre deformare il cavo orale come quando invece pronunciamo a, e, i, o, u. Per questo, a livello concettuale mi pareva il simbolo ideale per indicare una sorta di “neutro” riferito alle persone. Detto questo, non l’ho mai pensato come la soluzione definitiva, ma piuttosto come una specie di “evidenziatore” dell’esistenza di una doppia istanza: ci sono persone scontente che nel plurale si usi il maschile sovraesteso (anche se ci sono 50 donne e un maschio) e altre che invece non si riconoscono né nel maschile né nel femminile (ad esempio, le persone che si definiscono “non binarie”). Io non ho proposte concrete da fare per risolvere il problema. In compenso, noto che lo schwa piace a molti creativi e attira l’attenzione sulla questione. Al momento, ciò mi pare importante.
Lavoro da sempre a stretto contatto con il mondo della scuola, per cui non mi sento per nulla intrappolata in nicchie particolari. Sicuramente, non quella accademica, che in generale, a parte alcuni casi, mi considera abbastanza “aliena”. All’attivismo e alla militanza, invece, mi sono accostata da poco. È tutto un ambito nuovo, da esplorare, per quanto mi riguarda, al quale cerco di affacciarmi con la (per me) necessaria umiltà. Sicuramente sono interessata alle questioni che riguardano i “margini” della società (persone che possono subire discriminazioni per genere, etnia, orientamenti sessuali, disabilità, neuroatipicità, età ecc.), ma in questo campo devo imparare moltissimo. Per questo, cerco di ascoltare chi vive questi disagi in prima persona. Senza l’ascolto delle vittime, come ci ricorda il linguista e attivista Federico Faloppa, non serve a molto dichiararsi “inclusivi”.
Il bello di studenti e studentesse è che sono più elastici degli adulti: sono delle spugne, e occorrerebbe approfittare di questo per intavolare discussioni metalinguistiche anche a scuola (come diceva sempre Tullio De Mauro: facciamo un po’ di linguistica, di sociolinguistica, anche a scuola: sarebbe utile perché favorirebbe una maggiore apertura mentale in campo linguistico, e a cascata anche in altri contesti). Certo, poi c’è da considerare un altro aspetto: i ragazzi di oggi si sentono meno “schematizzati”, e al di là delle classiche offese sessiste (“frocio” a un maschio non abbastanza virile, “troia” a una ragazza percepita come eccessivamente disinibita), i giovanissimi sono molto più tranquilli rispetto alle questioni di genere, magari mi dicono “ma queste questioni sono superate, noi ci sentiamo fluidi”. Il che è bello, per quanto mi riguarda; ma li metto sempre in guardia da quello che troveranno poi affacciandosi al mondo del lavoro, dato che è un contesto in cui le discriminazioni di genere prosperano tuttora. Per questo, invito anche gli studenti con cui discuto a non sottovalutare la necessità di un femminismo sano, vòlto non ad affermare un fantomatico dominio della donna sull’uomo (femminismo come contrario del maschilismo), ma per cercare di costruire una società in cui ci sia parità nel rispetto delle differenze (femminismo come contrapposizione al patriarcato).
Sarà per la mia lunghissima vita social (25 anni!), ma io me la godo proprio, a divulgare. Poi chiaro, non sempre ci riesco, ma… devo dire che trovo più disagio a scrivere testi scientifici che non testi divulgativi. Va da sé, poi, che per divulgare bisogna studiare tanto, per evitare di dire e scrivere castronerie. Ma se c’è un aspetto del mio lavoro che mi piace particolarmente, è quello di cercare di tradurre nozioni anche complesse in qualcosa di fruibile dalla maggior parte delle persone. Parafrasando una famosa frase di Gramsci, per me non c’è cultura senza relazione.
Secondo me potremmo individuare due tipi di “disagiati linguistici”. Da una parte, abbiamo coloro che non sanno di non sapere (ossia, le persone vittime del famoso “effetto Dunning-Kruger”: meno sanno, più pensano di sapere); di solito sono persone che hanno frequentato la scuola dell’obbligo, magari anche le superiori, ma che poi hanno smesso di “coltivare la lingua”, fossilizzandosi su un livello di conoscenza media che dà adito alle peggiori pedanterie. Dall’altra parte, ci sono invece i “supercolti”, che magari hanno competenze molto approfondite (anche in campo linguistico), ma che si sono, da anni, rifugiati nella proverbiale “torre d’avorio”, magari schifando un po’ la gente. Penso che chi ha studiato molto faccia altrettanta fatica ad accettare che magari le cose non sono più come le ha imparate lui o lei, e che questo crei a sua volta un disagio soprattutto nella relazione con i non specialisti. Anche perché per queste persone la lingua è anche un modo per difendere la propria posizione. La lingua è potere, no? Per cui, se io, esperto, parlo in maniera incomprensibile, mi presento come una sorta di stregone tenutario di un sapere superiore. Però, nel fare questo, molti di questi super-esperti perdono via via contatto con le persone e la realtà linguistica. Con conseguenze spiacevoli.
È come se le lamentele per lo stato della nostra lingua arrivassero, in breve, da due direzioni diverse, entrambe accomunate dal fastidio per il cambiamento, visto come la rovina di uno status quo linguistico.
Vera Gheno nasce in Ungheria nel 1975. Si laurea e si addottora in Linguistica presso l'Università di Firenze, specializzandosi sulla comunicazione mediata dal computer. Tra le sue ultime pubblicazioni, oltre a quelle menzionate nel testo, Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, Longanesi 2018.
Fabiano Mari è co-animatore di Tamu Edizioni e della libreria Tamu.