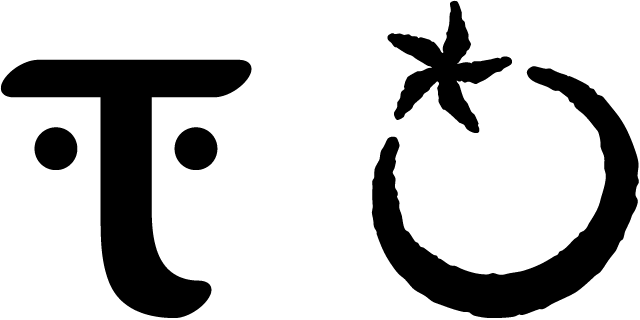Agli albori della techno, la musica dei Drexciya racconta di un mito subacqueo fatto di donne africane incinte che, morte in mare durante il Middle Passage, generano figli mutanti capaci di vivere negli abissi dell'Oceano Atlantico. Sullo sfondo della produzione del collettivo troviamo la Detroit post-industriale, dove la techno ha prosperato, intessendo un rapporto tra musica e città che ci obbliga a una riflessione su diaspora, migrazione e nuove modalità di lotta politica.
Ascoltando Species of The Pod, Drexciya,
Neptune’s Lair, 1999.
In quella immensa esperienza artistica che chiamiamo collettivamente «musica» esistono infinite storie: aneddoti, vicende, episodi che raccontano aspetti che spesso travalicano la dimensione strettamente musicale per toccare la vita e la biografia degli artisti. Più raramente, poi, esistono storie, spesso dimenticate o comunque scarsamente conosciute, che riescono a congiungere il vissuto con il suono, generando effetti esplosivi, tanto artisticamente quanto addirittura politicamente.
I Drexciya sono stati un progetto musicale nato a Detroit nel 1991, dal duo di dj e producer composto da James Stinson e Gerald Donald, e durato fino al 2002, anno della morte di Stinson. Negli anni della loro attività producono sonorità inconfondibili, abissali e al contempo acide, tanto acquatiche e liquide quanto ritmiche e ripetitive, dimostrando l’ampiezza di possibilità sonore offerte dall’utilizzo di sintetizzatori e drum machine. Oltre all’innegabile influenza esercitata sulla musica elettronica, è la mitologia costruita dal collettivo stesso – a cui sin dal nome fanno riferimento – ad apparire interessante, specialmente se collocata nello spazio urbano e sociale entro e da cui la loro musica prende forma. Quella dei Drexciya è infatti una vicenda artistica che intreccia molteplici piani che possiamo qui ricondurre, per semplicità, a tre questioni fondamentali: in primo luogo, troviamo il tema dello schiavismo, del Middle Passage e della diaspora africana; inoltre, fondamentale è il rapporto con Detroit, tanto con il cambiamento urbano di una metropoli post-industriale, quanto con la condizione di classe razzializzata degli afroamericani negli Stati Uniti; infine, non possiamo di certo ignorare quell’afrofuturismo incarnato e praticato dal collettivo, che mobilita questi elementi non solo per indagarli e ricordarli ma soprattutto per immaginare e costruire nuovi futuri e mondi alternativi.
Durante il Middle Passage, milioni di persone nere perdevano la vita durante il viaggio sulle navi schiaviste: se considerate malate, indisciplinate o inadatte al lavoro, spesso venivano gettate in mare dai bianchi; altre volte, però, erano loro stesse ad optare per questa forma di suicidio, nella prospettiva di sottrarsi allo schiavismo attraverso l’unica strada in quel momento possibile, la morte. Anche le donne furono vittime dello schiavismo: le cronache del periodo sono infatti popolate di storie di schiave che praticano la stessa forma di suicidio, con una ulteriore serie di implicazioni che ci portano dritti al cuore della mitologia drexciyana.
Come spiega efficacemente Kodwo Eshun, artista e teorico afrofuturista, nei credits del doppio CD The Quest del 1997, i Drexciya riferiscono il loro nome proprio a quelle donne gettatesi in mare per ribellarsi allo sfruttamento schiavistico, in particolare alle schiave africane incinte che morirono sui fondali marini, a volte perché considerate un carico scomodo, altre per loro stessa scelta, in modo da evitare un destino crudele ai figli che portavano in grembo. L’utero materno, tuttavia, può essere considerato un ambiente acquatico e ciò, come negli ancestrali racconti dei naviganti che si imbattevano nelle specie ibride che popolano i fondali marini, dagli uomini-pesce fino agli atlantidei, rende narrativamente credibile la possibilità che questi neonati sottratti alla schiavitù imparino sin da subito a respirare sott’acqua: Stinson e Donald immaginano e costruiscono dunque il mito dei Drexciyani, questi figli di schiavi, divenuti mutanti e dunque capaci di vivere negli abissi dell’Oceano Atlantico, che fondano un luogo di alterità, di libertà e di sottrazione rispetto ad ogni forma di oppressione vissuta in superficie.

Se il tentativo di portare alla memoria quella storia di ingiustizia che si condensa nel Middle Passage è esplicito fin dal principio, occorre fare qualche passo ulteriore per comprendere quanto per tale mitologia sia centrale anche una meditazione sulla questione diasporica, in particolare sul tema della doppia identità/doppia coscienza africana nella modernità. Non è casuale, in tal senso, che Kodwo Eshun consideri la mitologia Drexciya in riferimento al noto testo The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza di Paul Gilroy, sociologo e storico britannico nonché figura chiave degli attuali Black Studies. Eshun suggerisce infatti che quella del collettivo di Detroit è un’efficace speculazione musicale sul codice evolutivo della black subjectivity, che si nutre della reinterpretazione del libro di Gilroy in chiave sci-fi.
Uno dei tentativi centrali di The Black Atlantic è quello di delineare l’Atlantico Nero come uno spazio storico-culturale oltre che geografico, che comprende in sé tanto la rotta schiavista quanto altre e differenti esperienze di migrazione. Tale spazio obbliga a pensare una cultura slegata dai confini nazionali e dalle identità essenzializzate, rigide e monolitiche, aprendo invece ad un concetto di spazio globale e transnazionale, frutto degli spostamenti, degli incontri ma anche del dolore, delle ingiustizie e dei conflitti che lo compongono. Il viaggio e la migrazione sono i caratteri fondamentali di tale efficace soluzione concettuale e politica, che segnano del resto tutta l’ampiezza dell’intuizione di Gilroy: non è un entusiasmo idealistico per il viaggiatore-avventuriero quello che muove l’autore, quanto piuttosto la piena coscienza di come le soggettività nere siano state, e sono tuttora, codificate e costruite da esperienze della migrazione talvolta totalmente diverse tra loro.
A comprendere ulteriormente quanto quella di Gilroy non sia un’esaltazione del margine come sorta di privilegio politico ci aiuta il concetto di diaspora come condizione ibrida, tanto della cultura quanto dell’identità nera nel corso della modernità. Quella diasporica è una condizione che, se da un lato può produrre nuove forme culturali e politiche, dall’altro genera una strutturale e inconciliabile doppiezza identitaria nelle soggettività ibride e «meticce», impossibilitate a risalire a una propria origine chiara a causa dello sradicamento storicamente non solo agito, ma spesso e volentieri subito dal popolo africano nel suo differimento rispetto ad una stabile appartenenza di suolo che dovrebbe, almeno teoricamente, garantire una genealogia ben definita.
D’altra parte, non possiamo ignorare quanto il colonialismo e lo schiavismo abbiano contribuito alla costruzione attiva della condizione diasporica: il tema del ruolo giocato dalle navi nella formazione della complessa identità nera, che ci riporta oltretutto proprio alla mitologia Drexciya, è ben presente in Gilroy, che le descrive come vere e proprie entità politico-culturali, oltre che come veicoli di commercio, trasporto e spostamento. La nave dell’Atlantico Nero produce soggettività spesso in maniera terribile, attraverso lo sfruttamento, lo sradicamento forzato e la deportazione; non per questo può però sottrarsi alla correlata produzione di nuove forme di resistenza a cui il binomio colonizzatore-colonizzato necessariamente conduce. Se l’esercizio della volontà dell’oppressore sull’oppresso genera dei possibili tentativi alternativi e inediti di contro-soggettivazione e risignificazione del proprio posto nel mondo, l’utopia subacquea Drexciyana ne è allora un riuscitissimo esemplare.
La rielaborazione di tali questioni nella pratica artistica dei Drexciya si colloca in un contesto ben preciso, quello della città di Detroit, che ci fornisce un’ulteriore prospettiva, quella di classe, da cui è necessario guardare all’esperienza del collettivo. La Detroit degli anni ’90 è infatti una città post-industriale nel senso più materiale del termine: la decentralizzazione di grandi aziende di produzione automobilistica come Ford e General Motors, di cui la città era stata sede principale, determina non solo economicamente la forma della città. L’urbanistica e l’architettura di Detroit sono figlie della presenza di gigantesche fabbriche abbandonate, scheletri di cemento popolati da macchinari inutilizzati. A tale spopolamento industriale va aggiunta una rigida compartimentalizzazione dei quartieri, tanto in chiave razziale quanto di classe, un processo a cui tuttavia i giovani artisti afroamericani, e in particolare quella che sarebbe diventata la primissima scena techno, tentano di ribellarsi andando ad abitare proprio il cuore di quella fantasmatica città futuristica, dove sorgono le grandi fabbriche abbandonate. Non è soltanto l’oggettiva convenienza degli affitti a spingere questi giovani a scegliere la Downtown piuttosto che la periferia borghese statunitense, è il modo in cui quella Detroit «macchinica» suona e risuona a rendere il centro città un polo artistico e musicale. La promessa mancata del capitalismo americano, l’utopia tecnologica fallita, la segregazione economica e razzista/razziale, producono un deserto a partire dal quale tutto è però ancora possibile, tanto un nuovo suono quanto nuove forme di lotta politica e culturale tecnologicamente orientate verso il futuro.

Nelle sue Tesi di Filosofia della Storia, Walter Benjamin scriveva così:
Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo ‘come propriamente è stato’. Significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell'istante di un pericolo. Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono. Esso è lo stesso per entrambi: di ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla.
Se l’afrofuturismo è l’attualizzazione di storie dimenticate dai saperi tradizionali, i brani dei Drexciya condensano proprio tale incontro-scontro tra passato e presente, dirigendo entrambi interamente verso il futuro. Del resto, è ciò che fa parallelamente la loro mitologia: attraverso il racconto di un’utopia tutta particolare – diversa dalla maggior parte degli orizzonti utopici trascendenti a cui siamo abituati poiché immanente, situata cioè nel qui ed ora dell’Atlantico Nero, nelle profondità di un Oceano Atlantico che, pur rimandando ad un altrove, resta collocato e geograficamente situato – viene rifiutato ogni attendismo per poter esercitare attivamente, a partire dal presente, quel futurismo africano che costituisce un’alternativa critica rispetto alla realtà concreta di una nazione che si sforza ipocritamente di dimenticare e rimuovere la strutturale violenza che la fonda.
Per quelle ragazze e quei ragazzi afroamericani, organizzare eventi, riunirsi per ballare, scoprire nuovi artisti, scambiarsi dischi, collaborare per imparare a mixare o a produrre brani, trasmettere storie perdute attraverso tutto ciò, equivaleva a mettersi in cammino per divenire già da subito quel popolo delle profondità abissali, trasformando così la città e le sue fabbriche in una navicella marina lanciata a tutta velocità verso dei futuri, ancora interamente da inventare, che fossero veramente nelle loro mani.
L’Utopia subacquea è adesso,
long live Drexciya!
Bibliografia minima suggerita
Attimonelli C., 2018, Techno. Ritmi Afrofuturisti, Meltemi, Milano
Eshun K., 2003, Further Considerations on Afrofuturism, «CR: The New Centennial Review», 3, 2, pp. 287–302
Eshun K., 2021, Più brillante del sole. Avventure nella fantasonica, Nero Not, Roma
Gilroy P., 2019, The Black Atlantic: l’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Meltemi, Milano
Mellino M., 2021, La critica postcoloniale: decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies, Meltemi, Milano
Sicko D., 2014, Techno Rebels: The Renegades of Electronic Funk, Wayne State University Press, Detroit
Simone Zanello si è laureato nel 2022 in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Attualmente si occupa del rapporto tra psichiatria e politica nel post-strutturalismo, nel pensiero della decolonizzazione e nella postcolonial theory.