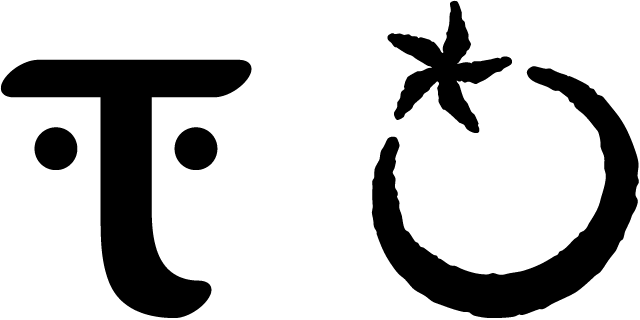Con buona pace di ogni istinto consolatorio ed autoassolutorio, la quotidianità pandemica ha messo fine ad ogni ritorno ad «orrende» normalità. Contro ogni finta catarsi e presunta soluzione tecnica, la celebrata serie Treme ci aiuta a stabilire delle coordinate di un nuovo contropotere.
God gave Noah the rainbow sign; no more water, Fire Next Time.
(«Dio mostró a Noé un arcobaleno; niente più acqua, la prossima volta il fuoco»)
Come nel solco tracciato precedentemente da tutte le produzioni che portano il marchio di David Simon, anche Treme – per citare una riflessione di Carlo Mazza Smiraglia per Il Tascabile a proposito di The Deuce – trae la propria forza dall’ambiguità del reale (un’apertura che spinge al di là di ogni semplice funzione autoriale). Più che un cristallizzato affresco storico e sociale, ciò che emerge dalla visione appare bensì un complesso dipanarsi di reti relazionali, di ecologie sociali e politiche, espresse e rafforzate a loro volta da personaggi che esprimono funzioni e pratiche esperienziali opposte a convenzionalmente scisse e frammentate personalità distinte. Il fascino della serie e il suo complesso articolarsi divengono quantomeno disturbanti nel momento in cui ci si ritrova a vederla durante il lockdown, quando ormai parole come spillover sono entrate nel vissuto quotidiano e la crisi ecologica – con connessi eventi estremi tradotti in «regolari» – diventa un’inevitabile presenza e non più un’oscura minaccia futura (almeno sembrava esserlo da questa parte del pianeta).
Da questo punto di vista, la grande forza di Treme consiste anche nel rifiutare l’uso (se non in maniera ridotta nei titoli di testa) delle immagini dell’uragano e del suo impatto. Non si cede mai all’estetica della narrazione catastrofica e, soprattutto, al senso di eccezionalità di cui essa si fa portatrice, spesso rafforzata dalla presenza di benevoli agenti della provvidenza in grado di fornire senso e direzioni a tali sciagure (ogni allusione a fatti e persone reali è voluto). Quella del disastro diviene una temporalità costante, a volte sinistramente legata ad un lungo processo di deterioramento, una violenza lenta (o slow violence/death direbbe Rob Nixon), che porta con sé una costante e progressiva precarizzazione dell’esistenza soprattutto per quanto riguarda le fasce della popolazione più vulnerabili e aggiungerei «sacrificabili».
Fra i/le protagonist*, ci sono figure che si adattano, che riescono tutto sommato a coesistere con la crisi, o a viverla con un certo livello di sicurezza grazie al proprio privilegio di classe (interconnesso a posizionamenti sulla linea della razza e del genere). C’è chi, da buon gig-worker della musica, continua per un po’ a vivere alla giornata, come il trombonista Antoine Batiste (Wendell Pierce) o altr*, come LaDonna (Khandi Alexander), Terry (David Morse) e Janette (Kim Dickens), che sembrano forzat* a scappare, a rinunciare al proprio territorio e al proprio vissuto e ciononostante resistono anche a caro costo (soprattutto nel caso della prima). D’altra parte, invece, personaggi come Creighton Bernette (John Goodman) esperiscono e incorporano l’uragano e il suo impatto come un inemendabile punto di rottura, la fine di un sogno di una città che era ed è destinato a sopravvivere solo ad uso e consumo di nuove frotte di turist* assetat* di commerciali immagini oleografiche. Da questo punto di vista, il territorio, o la molteplicità di geografie descritte dalla serie, appaiono come un campo di battaglia teso fra diversissime tensioni, come efficacemente incarnato dalla lotta di Albert «Big Chief» Lambreaux (Clarke Peters), fiero portavoce di un gruppo di Indian Reds (uno dei gruppi di danza popolare tipici delle celebrazioni del carnevale di New Orleans). Più che difendere una chiusa identità, ottusamente legata al feticcio della tradizione, l’imperterrita volontà di questo personaggio di portare avanti le celebrazioni (nonostante la dispersione del suo gruppo e la perdita di strutture di organizzazione collettiva) incarna il desiderio di non far scomparire la complessità di questo tessuto sociale.

Proprio all’interno di queste dinamiche di potere, la cura diventa o può diventare, come già evidenziato da una vasta letteratura, non tanto una forma pietistica di tolleranza e compassione (facile da cooptare proprio per permettere la classica riproduzione della forza lavoro), quanto la base di un possibile contropotere. La vicinanza e comunanza dei personaggi della serie riflette in primo luogo il desiderio di politicizzare il vivente, di costruirlo conflittualmente su un piano immanente e condiviso (seppur differenziato e variamente «situato»). In questo senso, Treme presenta una piena coscienza ecologica, mostrandoci un pianeta fragilmente (almeno per noi animali umani) «infetto», in cui la decomposizione di una rete urbana porta con sé l’emersione di fatali malattie respiratorie (questo è proprio il caso di Big Chief che quasi sembra profetizzare l’I can’t breathe di George Floyd) e il continuo sgretolarsi della potenza relazionale. Costruire una «controrete» di cura significa, pertanto, rifiutare un presente posizionamento, soprattutto laddove questo viene articolato come ineluttabile e necessario, e affermare nuovi spazi, altri modi di essere insieme contro ogni passione triste.
Tornando all’iniziale monito «biblico» di Baldwin, può darsi che il fuoco sia già qui con noi, e allora che fare? La serie risponde già con la sua scena iniziale (con la canzone I feel like funkin’ it up).
C’è un mondo da guadagnare (ci dice Sandro Mezzadra), proviamo a comporne le note assieme.
Francesco Sticchi, Lecturer in Film Studies presso la Oxford Brookes University e il SAE Institute; si occupa di Film-Philosophy e Cinema della Precarietà ed è attivista del collettivo Terra Phoenix.