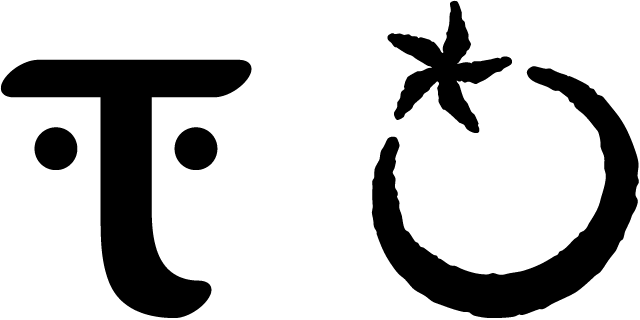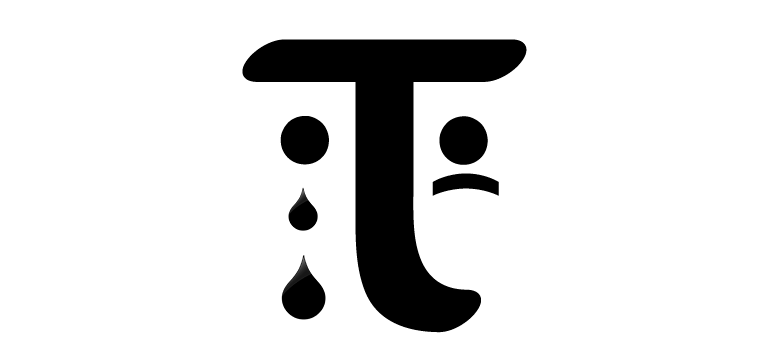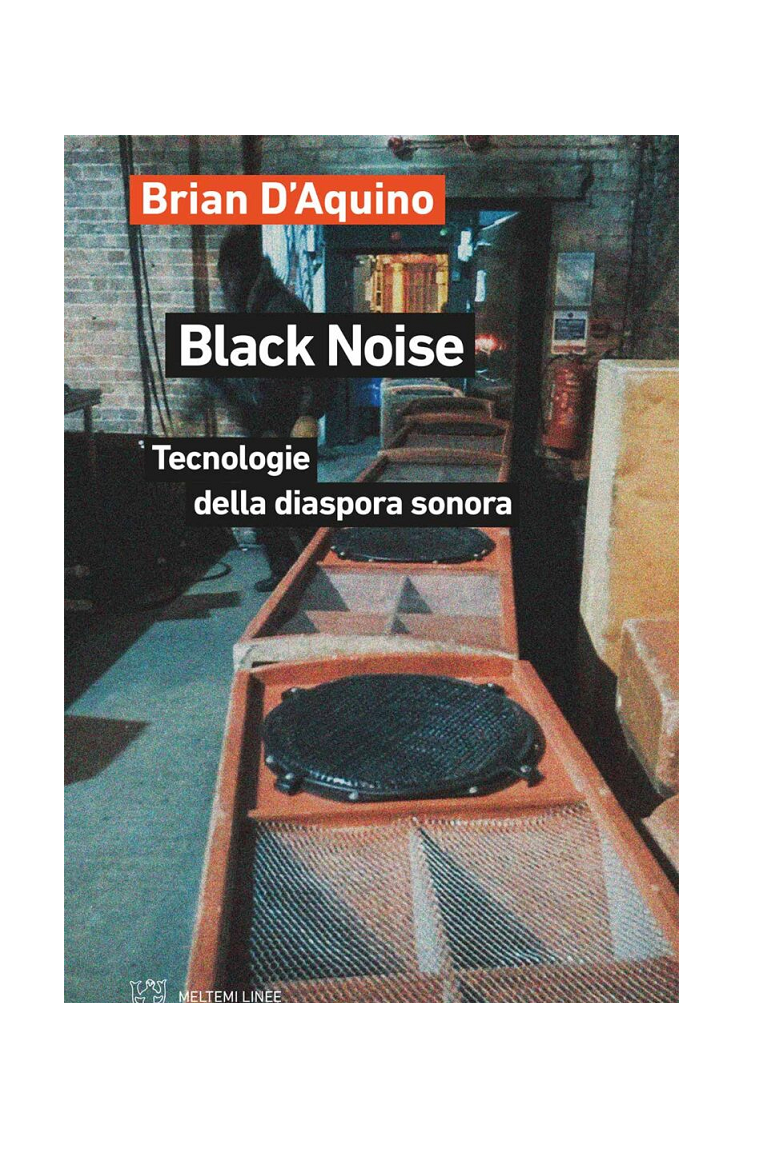Qual è la consistenza della linea che divide il suono dal rumore? Con quali armi si combatte la battaglia per lo spazio acustico nelle città? In che modo il sound di una piccola isola dei Caraibi è riuscito a esercitare un’influenza tanto profonda sulla musica pop ed elettronica del nuovo millennio? Pubblichiamo un estratto da Black noise. Tecnologie della diaspora sonora (Meltemi) di Brian D'Aquino, ringraziando l'autore per la disponibilità.
Ogni ballo giunge al termine, ogni nastro arriva a fine corsa. A musica spenta ciò che resta è un vago senso di vuoto, una lieta spossatezza dei muscoli, la consapevolezza di aver partecipato a qualcosa di importante e irripetibile, denso quanto impalpabile. L’assenza di tutto ciò che era prima lascia spazio a una domanda: dove va a finire il suono che non si riesce più a udire? Secondo una credenza diffusa in epoca medievale i suoni non svaniscono, ma continuano a riverberare nell’audiosfera in eterno, proiettati verso distanze superiori alle capacità dell’orecchio umano. Più che una concezione sorpassata, l’idea medievale rimanda a una sorta di weird science, pratica occulta e magia del suono che, almeno in parte, risuona con gli argomenti qui trattati.
Ciò che questo libro si è proposto di fare è poco più che fornire i mezzi per accordare le orecchie e il corpo a un suono specifico. Una frequenza bellicosa sotto la mappa della modernità occidentale. Il segreto di una ingegneria sonora non autorizzata. Il primo e più tenace parassita musicale. Il ladro rapito e derubato a sua volta. Black noise: il suono come eccesso del regime di visibilità, e l’arma vincente nella battaglia per la conquista della pista da ballo. Una volta raggiunto questo scopo, si è tentato di seguirne le tracce all’interno di una camera d’eco planetaria, attraverso un movimento fatto di azione e reazione, riflessione e rifrazione, amplificazione e saturazione. Qui, in un feedback che finisce per nutrire sé stesso, punti lontani nel tempo e nello spazio guadagnano prossimità inaspettate, origine e fine si confondono. Non è dunque semplice tirare le fila della discussione, legiferare la fine del movimento, ritirare le mani dalla cacofonia di suoni schizofonici, ripetuti, rimbalzati che – lungi dal raggiungere lo stato di quiete – restano invece sospesi con tutto il peso di una materialità che interroga piuttosto che spiegare, problematizza piuttosto che semplificare. E che intanto, chiaramente, continua a far muovere i piedi.
Mentre questo libro viene ultimato, uno sconvolgimento planetario assolutamente imprevisto ha sparigliato una volta di più le carte sul tavolo. La pandemia ha avuto successo in ciò che a nessuna autorità era riuscito: silenziare il pianeta. Dalla Giamaica al Sudafrica, dall’Europa al Sud America, la trasmissione del rumore nero si è improvvisamente interrotta. Come è accaduto per il resto delle relazioni sociali, Internet ha in parte aiutato anche i nuovi orfani del rumore a sopportare il peso dell’impatto con il regime del distanziamento sociale. Con il settore dell’intrattenimento – sia ufficiale che sotterraneo – paralizzato, lo spettro di una digitalizzazione forzata e totale interroga il black noise nella sua dimensione più intima. Se per il suono l’ambiente digitale aumenta esponenzialmente le possibilità ritmiche, lo spazio di azione nella dimensione dell’intensità si riduce precipitosamente. Al contrario di ciò che accade con la distorsione analogica, indugiare nel rosso non attiva necessariamente piacere, né terrore; tradotto in soglia numerica, il clip segnala unicamente la perdita dell’informazione.
Un’altra questione è relativa alle strategie di sussistenza sul medio e lungo periodo. Pur offrendo ristoro e sostegno a comunità disgiunte come mai prima d’ora, la moltiplicazione della musica su social media e piattaforme di streaming ha reso ancor più urgente la necessità di ripensare lo spazio digitale e la nostra partecipazione a esso proprio a partire dalla proprietà delle piattaforme e delle stesse infrastrutture che ne garantiscono il funzionamento. La sfida riguarda pertanto l’elaborazione di strategie nuove al fine di intercettare parte dei flussi di denaro che la permanenza in rete movimenta, e distribuirli affinché nessuno – soprattutto le figure più fragili e meno in vista delle comunità che nel rumore trovano il proprio sostentamento – rimanga troppo indietro.
Tuttavia, ogni sistema resta pur sempre una formazione instabile: l’equilibrio non è mai duraturo. Sfidando le limitazioni imposte dalla pandemia, il rumore nero è inaspettatamente tornato a occupare le strade. La scintilla è stata una frase strozzata, poco più di un rumore – I can’t breathe, non riesco a respirare – pronunciata sull’asfalto di Minneapolis. L’eco delle parole di George Floyd si è unita a quelle di Eric Garner, Michael Brown, Kenneth Chamberlain e Trayvon Martin, a quelle non registrate di Breonna Taylor, e a tutte le altre che continuano a riverberare nell’audiosfera senza essere ascoltate. Crescendo in ampiezza e intensità, ha attraversato oceani e continenti, occupato strade e piazze, bruciato questure e abbattuto statue, interrompendo finalmente il monologo del rumore bianco amplificato dai media mainstream, e mobilitando un insorgente assemblaggio planetario attorno a un imperativo antico quanto urgente: le vite nere contano.
Interrogarsi circa le conclusioni in un simile scenario ha dunque qualcosa in comune con l’antica domanda: dove va a finire il suono quando cessa di essere udibile? E soprattutto, cosa resta delle storie che nel suono sono conservate, delle identità che con il suono si sono costituite, dei corpi che attorno al suono si sono radunati e in esso sono affondati – in altre parole, di quella impurità costitutiva che non può essere elusa né cancellata?
Ancora una volta, la risposta è da ricercarsi nel processo, e non nel prodotto. Nel metodo più che nel risultato. Così come il suono è stato assemblato, amplificato, remixato, impacchettato e venduto ai quattro angoli del pianeta, allo stesso modo storie, corpi e identità mutano e cambiano forma, si evolvono e regrediscono, si combattono e firmano trattati. Ogni mappa non può pertanto che essere temporanea: una fotografia sonora del banco di missaggio un attimo prima di spingere il tasto play, far partire il nastro, e lasciare che il dubmaster faccia ciò che meglio sa fare. Ripetuto infinite volte, il mix sarà ogni volta, inevitabilmente, diverso. Ciò nonostante, sarà probabilmente possibile ritrovare una coerenza di fondo, seppur sfuggente alla presa delle parole. Un certo peso, un vago calore o colore del suono, che di un determinato studio è il marchio di fabbrica.

In altre parole, si è cercato di rendere percepibili le piccole variazioni di tensione, i picchi di volume e le azzardate equalizzazioni che sostengono l’idea di black noise come una coerente formazione audiopolitica. Da qui si è cercato di suggerire un modo per ripensare le modalità classiche della critica culturale della musica, che possa muovere oltre il descrittivismo e l’autoritarismo – spesso intrecciati – che non di rado risuonano nelle parole che attorno alla musica vengono prodotte. Andare oltre l’ossessione per le identità e la loro rappresentazione, per indirizzare l’attenzione verso la materialità dei processi – meccanici, sociali, economici – che tali identità contribuiscono a formare. Nel fare della musica – e della sua dimensione fondamentale e spesso in ombra, quella sonora – un metodo, si è cercato inoltre di ripensare il valore politico di una serie di pratiche culturali proprio a partire da quel che resta, spesso indicibile, sicuramente illeggibile, sospeso nella materialità del suono stesso. Si è inoltre tentato in questo modo di dare conto di una versione più complessa dell’audiosfera come un’entità a un tempo vissuta e vivente, vibrante e stratificata, lontana da una concezione pastorale e più vicina alle dinamiche di una guerriglia diffusa in cui non esistono colpi proibiti.
Qui l’esperienza di una piccola isola dei Caraibi si rivela, ancora, sorprendentemente feconda di intuizioni e suggestioni, in un modo che impone di riconsiderare le linee invisibili che pretendono di organizzare – e disciplinare – quella complessa formazione culturale che siamo soliti chiamare modernità. Per chi ha orecchie ben sintonizzate, dunque, il rumore non svanisce, ma continua a sondare e risuonare lo spazio presente e il tempo a venire. E qui, ancora una volta, who feels it, knows it.
Credits foto della copertina: astarbene.com
Brian D'Aquino è dottore di ricerca in Studi internazionali, dj e produttore musicale. Collabora con il Centro Studi Postcoloniali e di Genere e con la Technoculture Research Unit presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ed è tra i fondatori del gruppo di ricerca Sound System Outernational. Dal 2004 suona il Bababoom Hi Fi Sound System.