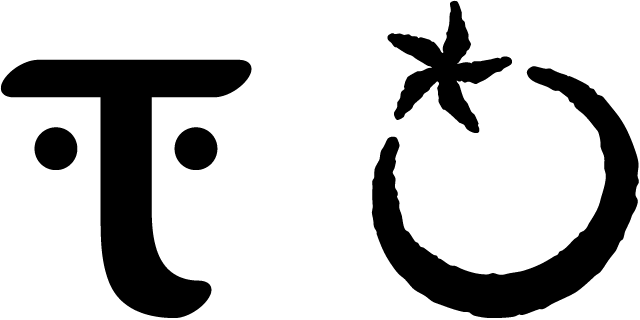Dalla corrispondenza tra John Berger e il subcomandante Marcos, una lettera in cui il critico d’arte e saggista si sofferma sull’importanza delle pietre nell’interpretare la formazione politica e umana di Antonio Gramsci. L’assenza di dogmatismo nel pensiero di Gramsci, per Berger, deriva da quella speciale pazienza e da quel senso del tempo che gli sono stati ispirati dalla vita in Sardegna.
Marcos, voglio dirti qualcosa a proposito di una sacca di resistenza. Una in particolare. Le mie osservazioni possono sembrare remote, ma come dici tu, «Un mondo può contenere molti mondi, può contenerli tutti».
La sua speciale pazienza proveniva da un senso della prassi che non finirà mai. Vide da vicino, e talora diresse, le lotte politiche del suo tempo, senza tuttavia dimenticare mai lo sfondo di un dramma ininterrotto il cui arco copre un numero incalcolabile di epoche. Forse fu questo a impedirgli di diventare, come tanti altri rivoluzionari, un millenarista. Credeva nella speranza anziché nelle promesse e la speranza è una faccenda di lungo periodo. Possiamo sentirlo nelle sue parole:
Se ci pensiamo, vediamo che ponendoci la domanda che cosa è l’uomo vogliamo dire: che cosa l’uomo può diventare, se cioè l’uomo può dominare il proprio destino, può «farsi», può crearsi una vita. Diciamo dunque che l’uomo è un processo e precisamente è il processo dei suoi atti.
[Quaderno 10 (XXXIII), § (54)]
Nell’entroterra intorno a Ghilarza, come in molte zone dell’isola, ciò che si avverte di più è la presenza delle pietre. È innanzitutto un luogo di pietre e – su in cielo – di cornacchie grigie. Ogni tanca – terreno a pascolo – e ogni sughereto ha almeno uno, di frequente più cumuli di pietre, e ogni cumulo ha le dimensioni di un grande camion merci. Queste pietre sono state raccolte e accatastate di recente affinché il suolo, secco e povero com’è, possa comunque essere lavorato. Le pietre sono enormi, la più piccola peserà mezza tonnellata. Ci sono graniti (rossi e neri), scisto, calcare, arenaria e diverse rocce vulcaniche scure come il basalto. In alcune tancas i massi raccolti sono oblunghi anziché rotondi, perciò sono stati affastellati come pertiche e il mucchio ha una forma triangolare simile a quella di un immenso wigwam di pietra.
Muri a secco senza fine e senza età separano le tancas, costeggiano le strade sterrate, racchiudono recinti per le pecore o, sgretolati dopo secoli d’uso, fanno pensare a labirinti in rovina. Ci sono anche modeste pile piramidali di pietre più piccole, non più grandi di un pugno. Verso ovest si innalzano antichissime montagne calcaree.
Qui ogni pietra tocca una pietra. E qui, su questo terreno spietato, ci si accosta a qualcosa di delicato: c’è un modo di mettere una pietra sull’altra che annuncia indiscutibilmente un gesto umano, così diverso da un caso naturale. E ciò può ricordare che contrassegnare un luogo con un tumulo costituiva una sorta di denominazione e fu probabilmente tra i primi segni usati dall'uomo.
La conoscenza è potere [scrive Gramsci]. Ma il problema è complesso anche per un altro aspetto: che non basta conoscere l’insieme dei rapporti in quanto esistono in un momento dato come un dato sistema, ma importa conoscerli geneticamente, nel loro moto di formazione, poiché ogni individuo non solo è la sintesi dei rapporti esistenti ma anche della storia di questi rapporti, cioè è il riassunto di tutto il passato.
[Quaderno 10 (XXXIII) § (54)]

Di conseguenza i sardi diffidano del mare e lo detestano. «Chiunque arrivi dal mare», dicono, «è un ladro». Non sono un popolo di marinai o pescatori, ma di pastori. Hanno sempre cercato rifugio nell’interno roccioso e inaccessibile della loro terra per diventare ciò che gli invasori chiamavano (e chiamano) «briganti». L’isola non è grande (250 km × 100 km), eppure i monti iridescenti, la luce meridionale, la sua siccità da lucertole, i burroni, l’ondulazione del terreno sassoso le danno, se la si osserva da un punto culminante, l’aspetto di un continente! E su questo continente oggi, insieme ai suoi tre milioni e mezzo di pecore e alle sue capre, vivono trentacinquemila pastori: centomila se si includono le famiglie che lavorano con loro.
È una terra megalitica, non nel senso di preistorica: come tutti i paesi poveri del mondo ha una propria storia ignorata o considerata «selvaggia» dalla metropoli. È una terra megalitica nel senso che la sua anima è roccia e sua madre pietra. Sebastiano Satta (1867-1914), il poeta nazionale, scriveva:
Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti
Tu lo dovrai, Sardegna, ai nuovi figli.
Ci vuole tempo perché gli occhi si abituino all’oscurità che li popola. L’unica entrata, con un architrave di pietra intagliato, è stretta e bassa; bisogna accovacciarsi per entrare. Quando nell’interno buio e fresco si torna a vedere, si nota che per ottenere una volta senza malta gli strati di pietre massicce hanno dovuto essere disposti l’uno sull’altro a strapiombo verso l’interno, di modo che lo spazio è conico come quello di un alveare di paglia. Il cono, tuttavia, non può essere troppo appuntito, perché le pareti devono sostenere il peso delle enormi pietre piatte che chiudono il tetto. Alcuni nuraghi sono a due piani, con una scala. A differenza delle piramidi, costruite un migliaio di anni prima, queste strutture erano destinate ai vivi. Sulla loro esatta funzione esistono varie teorie. Quel che è chiaro è che offrivano protezione, probabilmente molti livelli di protezione, perché gli uomini sono complessi.

All’interno, si diventa a poco a poco coscienti del silenzio. All’esterno ci sono more, molto piccole e dolci, fichi d’India dei cui frutti dai semi di pietra i pastori si cibano dopo averli ripuliti delle spine, siepi di rovi, filo spinato, asfodeli simili a spade le cui else sono state piantate nel suolo sottile… forse uno stormo di fanelli canterini. All’interno dell’alveare di pietre (costruito prime delle guerre di Troia), silenzio. Un silenzio concentrato – come il concentrato di pomodoro in lattina.
Il vasto e diffuso silenzio va invece di continuo monitorato nel caso un rumore annunci un pericolo. In questo silenzio concentrato i sensi percepiscono il silenzio come una protezione. Così ci si accorge della compagnia della pietra.
Gli epiteti di «inorganico», «inerte», «inanimato», «cieco» – applicati a una pietra – non sono probabilmente che abbreviazioni. Sopra la cittadina di Galtelli torreggia il massiccio calcareo chiamato monte Tuttavista – la montagna che vede tutto.
Forse la natura proverbiale della pietra è cambiata quando la preistoria è diventata storia. Gli edifici sono diventati rettangolari. La malta consentiva la costruzione di archi puri. Si è stabilito un ordine, all’apparenza permanente, e a quest’ordine si è accompagnata la nozione di felicità. L’arte dell’architettura cita in vari modi questa nozione, eppure per i più la felicità promessa non è arrivata, ed è cominciato il biasimo proverbiale: la pietra veniva contrapposta al pane perché non era commestibile; la pietra era definita senza cuore perché era sorda.
Prima, quando l’ordine era sempre mutevole e la sola promessa era quella racchiusa nei luoghi che offrivano protezione, ai tempi dei nuraghi, le pietre erano considerate compagne.
Le pietre propongono un altro senso del tempo, nel quale il passato, il passato profondo del pianeta, offre un sostegno, esile eppure massiccio, agli atti di resistenza umana, come se le vene di metallo della roccia portassero alle nostre vene di sangue. Mettere una pietra in posizione verticale è un riconoscimento simbolico; la pietra diventa una presenza; inizia un dialogo. Vicino alla cittadina di Macomer ci sono sei di questi massi sommariamente scolpiti a forma di ogiva; tre di essi, all’altezza delle spalle, hanno seni intagliati. Il rilievo è minimo. Non necessariamente per mancanza di mezzi; forse per scelta. Una pietra in posizione eretta non rappresentava un compagno: era un compagno. I sei betili sono in trachite, una roccia porosa. Di conseguenza, anche sotto un sole forte, raggiungono il calore del corpo e non di più.
Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti
Tu lo dovrai, Sardegna, ai nuovi figli.
Più antiche dei nuraghisono le domus de janas, stanze scavate su costoni in cui affiorava la roccia viva e destinate, si dice, a ospitare i morti.
Questa è fatta di granito. Ci entri strisciando e all’interno puoi stare seduto ma non in piedi. Le stanze misurano tre metri per due. Incollati alla pietra ci sono due nidi di vespe abbandonati. Il silenzio è meno concentrato che nei nuraghie c’è più luce, perché si è meno profondamente all’interno; la tasca è più vicina all’esterno del cappotto.
Qui l’età del luogo creato dall’uomo è palpabile. Non perché calcoli… Neolitico medio… Calcolitico, ma grazie alla relazione tra la roccia in cui ti trovi e il tocco umano.
La superficie granitica è stata intenzionalmente levigata. Non è rimasto nulla di ruvido o frastagliato. Gli utensili erano probabilmente in ossidiana. Lo spazio è corporeo in quanto sembra pulsare come l’organo di un corpo. (Un po’ come la tasca di un canguro!) E l’effetto è accresciuto dalle leggere sbavature di ocra giallo e rossiccio là dove le pareti erano in origine dipinte. Le irregolarità del rilievo devono essere state determinate da variazioni nella formazione della roccia. Ma più interessante della loro provenienza è la loro direzione.
Te ne stai disteso in questo nascondiglio, Marcos – c’è un odore dolciastro, quasi di vaniglia, che proviene da una qualche erba all’esterno – e nelle irregolarità riesci a vedere i primi rilevamenti verso la forma di una colonna, il profilo di un pilastro o le curve di una cupola – verso l’idea di felicità.
Ai piedi della stanza – e non c’è dubbio sul modo in cui i corpi, vivi o morti, dovevano giacere – la roccia è curva e concava e su questa superficie una mano umana ha intagliato diverse nervature che si irradiano come su una conchiglia.
Vicino all’entrata, che non è più alta di un cane di piccola taglia, c’era una sporgenza simile a una piega nel sipario naturale della roccia, e qui una mano umana l’ha assottigliata e arrotondata in modo che si avvicinasse – pur senza ancora raggiungerla – alla forma di una colonna.
Tutte le domus de janas guardano a est. Da dentro, attraverso l’entrata, si vede sorgere il sole.
In una lettera dal carcere del 1931 Gramsci racconta una storia per i propri figli, di cui, a causa della reclusione, non aveva mai visto il più piccolo. Un ragazzino dorme con un bicchiere di latte appoggiato per terra accanto al letto. Un topo beve il latte, il bambino si sveglia e trovando il bicchiere vuoto scoppia a piangere. Allora il topo va dalla capra e le chiede un po’ di latte. La capra non ne ha, ha bisogno di erba. Il topo va nel campo, e il campo non ha erba perché è troppo riarso. Il topo va al pozzo e il pozzo non ha acqua perché ha bisogno di essere riparato. Allora il bambino va dal muratore che non ha le pietre che ci vogliono. Infine il topo va dalla montagna e la montagna non vuole saperne nulla e sembra uno scheletro perché ha perso i suoi alberi. (Nel corso dell’ultimo secolo la Sardegna è stata radicalmente disboscata per fornire le traversine ferroviarie all’Italia continentale.) In cambio delle tue pietre, dice il topo alla montagna, il bambino, quando sarà grande, pianterà castagni e pini sulle tue pendici. Dopo di che la montagna accetta di dare le pietre. In seguito il bambino ha tanto di quel latte che ci si lava! Più tardi ancora, quando è ormai un uomo, pianta gli alberi, l’erosione cessa e la terra diventa fertile.
P.S. Nel comune di Ghilarza c’è un piccolo museo Gramsci, vicino alla scuola da lui frequentata. Fotografie. Copie di libri. Qualche lettera. E, in una teca di vetro, due pietre intagliate di forma rotonda, grandi come pompelmi. Da ragazzo Antonio si esercitava ogni giorno utilizzandole come pesi per rinforzare le spalle e correggere la malformazione della schiena.
Immagine di copertina: Perdas marmuradas (pietre mammellate) presso Macomer: tre betili femminili.
Immagine 1: Santuario di Santu Gantine di Sedilo: betilo mammellato nuragico e cippi funerari romani (tratto da La Sardegna nuragica, Edizioni Della Torre, 1977)
Immagine 2: Nuraghi (tratto da Archeologia della Sardegna preistorica e protostorica, Poliedro, 1997).
Elaborazione di greg olla.
© John Berger e John Berger Estate, 2001
John Berger (1926-2017) è stato uno scrittore, critico d’arte e pittore britannico, autore di romanzi e di numerosi saggi sulle arti visive.
Maria Nadotti (traduttrice) è una giornalista, saggista, consulente editoriale, curatrice e traduttrice delle opere di John Berger e di bell hooks in Elogio del margine/Scrivere al buio.