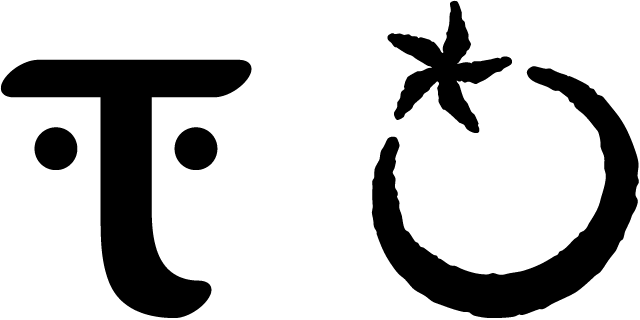Durante la pandemia, una serie di rappresentazioni del Meridione sono riaffiorate nelle spiegazioni di politici, giornaliste e opinionisti, parlando delle vite al sud e al contempo pretendendo, con un atteggiamento che potrebbe essere definito nordsplaining, di spiegarle in base ai loro modelli di conoscenza.
Inspiro profondamente, e provo a liquidarlo sbrigativamente con un “come vuoi che sia? Come in tutte le altre città, il virus avanza e la miseria pure". Le mie parole non bastano evidentemente al mio interlocutore, che insiste cercando di saperne di più, e poi, da sociologo in erba, si lancia con un domandone di quelli da un milione di euro, chiedendomi: “ma mi spieghi perché ogni volta che chiamo qualcuno lì a Napoli, mi capitano sempre disoccupati o persone che hanno perso da poco il lavoro?" Bingo, ho pensato. Ho l’opportunità di spiegare a qualcuno lassù, vagamente curioso, come le scelte politiche di questo paese, con la complicità di una borghesia locale arraffona, abbiano devastato una parte del suo territorio e dei suoi abitanti. Questo balena per un attimo per la mia testa, ma poi – non avendo voglia in realtà di proseguire la conversazione – opto per un’altra strategia e penso, tra me e me, che forse mi ha fornito quell’assist geniale di cui avevo bisogno per poter stoppare la fastidiosa telefonata, autoannoverandomi nella lista di disoccupati e straccioni della città.
“Non va proprio bene, Carmine" – mi risponde l’inconsapevole counseler, che nel frattempo aveva avuto come primissima audacia quella di chiedermi il nome. “Cosa ci resti a fare lì a Napoli? Se non hai lavoro, prendi la tua famiglia e i tuoi affetti e vattene al nord, all’estero, lì dove il lavoro si trova e viene valorizzato. Se non lavori, la tua vita non vale".
La mia risposta non ammette replica: con rammarico, soltanto successivamente ho considerato che fosse troppo poco aver trasformato il “vaffanculo", pronunciato con sdegno poco dopo aver pigiato il tasto rosso dello smartphone, in un semplice bip di chiusura della telefonata.
Quando mi sono tranquillizzato, ripensando a questa assurda conversazione, mi è tornata in mente una definizione che le femministe utilizzano ogni qual volta un esemplare umano della specie maschile fornisce loro spiegazioni non richieste su cosa dire o come comportarsi in determinate situazioni, quello che nel linguaggio corrente viene chiamato mansplaining. Un atteggiamento paternalista, insomma, ma che dice tanto del privilegio dell’uomo (bianco, etero e cis), e di come il suo punto di vista e le sue esperienze siano implicitamente da lui considerate più importanti, più autorevoli di quelle delle interlocutrici che ha di fronte, che magari – a differenza sua – le hanno vissute sulla propria pelle.
Un discorso, quello tipico del mansplaining, che non ho mai potuto subire – essendo appunto un uomo, piuttosto mi è sicuramente capitato di replicarlo – ma che ho vissuto altre centinaia di volte, in quanto terrone nato e cresciuto tra Napoli e la sua provincia e che ha girato un po’ il paese e l’Europa, in termini di nordsplaining. Le femministe mi perdoneranno e probabilmente comprenderanno il furto lessicale - che non giustifica certamente i numerosi atteggiamenti di minchiarimento da loro subiti da maschi meridionali – ma quando ho cominciato a pensare alle numerose volte in cui qualcuno ha provato a spiegarmi, con ragionevolezza, con ironia o talvolta anche con l’offesa cosa avrei dovuto fare e come avrei dovuto parlare (talvolta, anche con quale accento) in base alla mia provenienza, ho pensato che nessun altro termine potesse essere più azzeccato.
Mi porto dietro un’irrefrenabile curiosità rispetto a un atteggiamento del genere: perché le vite terrone importano così tanto al nordico consulente finanziario di turno? Cosa spinge una persona che chiama per propinarti un qualsiasi tipo di contratto a ergersi giudice della tua vita? Cosa gliene può fregare dei tuoi motivi per emigrare, del dolore al momento dei saluti ai tuoi affetti ogni volta che devi andare via dopo pochi giorni di visita, delle tue curiosità sul mondo che magari invece ti hanno spinto a viaggiare e non tornare? Cosa gliene importa di come (soprav)vivi quando invece resti? Quale morbosa ossessione muove le sue domande, le sue curiosità, la sua voglia di andare giù al sud “per ammirarne le bellezze" e passare poi il tempo in vacanza a contare con orgoglio la quantità di carte sporche lasciate per strada dai terun? Mi conforta pensare che, a ruoli invertiti (se io da Napoli gli avessi dovuto chiedere di come se la stavano passando con la pandemia al nord), non gli avrei mai fatto domande del genere, e che soltanto l’idea di porgliele mi avrebbe lasciato la sensazione di trattarlo come un oggetto esotico, inconoscibile ai miei occhi eppure così attraente.
D’altronde, la mia esperienza personale – come quella di tant* altr* terron*, emigrat* o meno – riflette una realtà storica lunga svariati secoli in cui un autoproclamatosi Nord pretende di spiegare il Sud, i suoi atteggiamenti e i suoi costumi. Ricercatrici e ricercatori afferenti agli studi decoloniali, riprendendo un ragionamento che Edward Said aveva già fatto a proposito del rapporto tra Occidente e Oriente, ci ricordano che il ruolo che gli europei si sono autoassegnati nel definire cos’è la modernità e nel ribadire dunque l’implicita superiorità della civiltà occidentale è strettamente correlato alla colonizzazione di altre civiltà, quelle delle Americhe. Si tratta di un rovesciamento di prospettiva importante, che lascia intendere come la nostra percezione della modernità non dipenda dall’arretratezza di altre culture e società, ma si fondi su rapporti di potere decisamente asimmetrici, costruiti a loro volta su un modello di pensiero in cui le variabili di razza e di genere costituiscono due assi fondamentali. Ritornando alla nostra Italia, con alcune differenze rilevanti, un’attitudine del genere ha segnato anche quella volontà di sapere, all’indomani dell’unificazione, dei patrioti risorgimentali, poi luogotenenti di Vittorio Emanuele II nelle regioni del sud, in gran parte di origine meridionale. Quest’ultimi spiegavano il Meridione a Cavour con un linguaggio coloniale e razziale fatto di Africa, beduini, delinquenti e camorristi, un linguaggio che avevano potuto apprendere soltanto dai loro pari europei e dalle loro “missioni civilizzatrici", e che giustificava la necessità di un intervento armato per reprimere le insurrezioni del brigantaggio nelle incivili regioni meridionali.
Questi clichés sono tutt’oggi ben radicati nell’inconscio collettivo italiano, in quel sentirsi parte di un’unica comunità (immaginata) nazionale in cui – anche ai tempi in cui questa sembra ri-unificata dalla “minaccia" dei migranti nel segno dell’odio e del razzismo – esiste sempre qualche italian* più civile, più progredit*, più sviluppat*, più europe* dell’altr*. E guarda caso questa gradazione di civiltà viene determinata dalla regione di appartenenza o provenienza o dall’accento, ovvero da segni vivi del proprio vissuto personale.
La pandemia ha riportato in superficie molte di queste rappresentazioni. Non che queste fossero scomparse: al contrario, nel loro essere latenti, sembrano solo essere rimaste troppo a lungo nelle tasche degli italiani, pronte per essere sfoderate ed usate all’occorrenza. Il nordsplaining, l’ipotesi che chiunque non abbia nel suo vissuto personale la provenienza da una delle regioni del sud, ma pretende di parlare, spiegare, interpretare per uno dei suoi abitanti, d’altronde non influenza solo le relazioni personali ma adora prendersi il suo spazio nel dibattito pubblico. E dà così adito a vari esemplari di nordsplainer.
Scorrendo un po’ a ritroso questi mesi pandemici, mi è tornata l’immagine del sincero democratico Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che sul finire del primo lockdown si è preso il gravoso compito di spiegare ai sardi, senza giri di parole, perché i turisti lombardi in arrivo per le vacanze estive non avrebbero dovuto essere sottoposti ai tamponi, così come trapelava dalle intenzioni delle istituzioni regionali. “Non penso che la Sardegna possa vivere solo di turismo autoctono. Sono i milanesi che, almeno in parte hanno inventato la Sardegna come meta turistica. Non dico che i sardi debbano esserci riconoscenti" – ha affermato in quella occasione Sala – “ma trattarci da untori no. Non è che ognuno si fa le sue regole". In questa spiegazione non richiesta sulla storia economica della Sardegna, espressa a tutela dei ricchi vacanzieri lumbard, sta tutta l’arroganza, particolarmente evidente durante l’emergenza economica-sociale seguita alla pandemia, di chi pensa di poter condizionare decisioni politiche altrui rivendicando il proprio ruolo di motore economico dello stato italiano.
La Sardegna ha monopolizzato l’attenzione mediatica nella prima estate da coronavirus almeno fino a quando non è toccato ai napoletani, in corrispondenza delle prime proteste, beccarsi la propria bella dose di nordsplaining. Qualche sera prima della telefonata con cui ho aperto quest’articolo, la giornalista Lucia Annunziata, chiede in diretta televisiva al sindaco di Napoli De Magistris delle ragioni delle proteste; nel mentre un inviato aveva appena intervistato un ragazzo manganellato dalla polizia. Stimolata da una domanda della conduttrice della trasmissione, Lucia Annunziata mette le mani avanti e dichiara di non essere la persona adatta a rispondere, poiché “pur affezionata alla città e nonostante ci vada spesso, non la conosco come la conoscono loro, sbaglierei a fare un’analisi". Una bella dichiarazione anti-nordsplaining, potrebbero pensare soddisfatt* le spettatrici e spettatori dal sud in ascolto, se questa non venisse immediatamente tradita dalla riflessione seguente, pronunciata sotto forma di una domanda ipocritamente curiosa e molto retorica, rivolta allo stesso De Magistris: “Sindaco, ma quell’individuo che è stato manganellato – lei che conosce bene i suoi concittadini – il linguaggio, il tatuaggio, il taglio di capelli… ma a che tipo di tribù sociale appartiene quello?". La scena è ulteriormente esplicitata dalla faccia di bronzo di chi crede di star ponendo una domanda assolutamente legittima senza accorgersi della violenza razziale e di classe intrinseca alle sue parole.
Così terminiamo questa carrellata di nordsplaining con Paolo Mieli, già ambiguo e sporadico alfiere della nostalgia neoborbonica, che manda in cortocircuito gli improbabili sportelli “difendi la città" indignando benpensanti napoletani e meridionali con una dichiarazione roboante: “Napoli ha potenzialità di insurrezione armata che altre regioni non hanno. Aspettiamoci cose inimmaginabili in pieno stile Gomorra". Una dichiarazione del genere, da parte di un opinionista così in vista, farebbe accapponare la pelle o sorridere a seconda della ricettività sensoriale di ognun* di noi, poiché rasenta quasi il parossismo. È una nord-spiegazione da prendere invece molto seriamente, poiché – dispiace ricordarlo - replica, quasi specularmente, l’atteggiamento di molti militant* oltre il Garigliano che, probabilmente annoiat* dalla propria vita civile, spesso cadono, senza rendersene conto, nella stessa tentazione di spiegare Napoli e il sud come luoghi restii alla civiltà e alle regole, in cui più facilmente potrebbe attecchire il seme della rivoluzione. In attesa sempre speranzosa di quest’ultima, non sarebbe male cominciare a pensare di fare carta straccia di nordsplainer di tutti i tipi.
Carmine Conelli è co-animatore dell’esperienza di Tamu Edizioni. Dopo aver conseguito un dottorato in Studi Internazionali all’Orientale di Napoli, lavorando sulla colonialità delle rappresentazioni dei meridionali ai tempi dell’unificazione italiana, si è dato alla fuga dal mondo accademico.