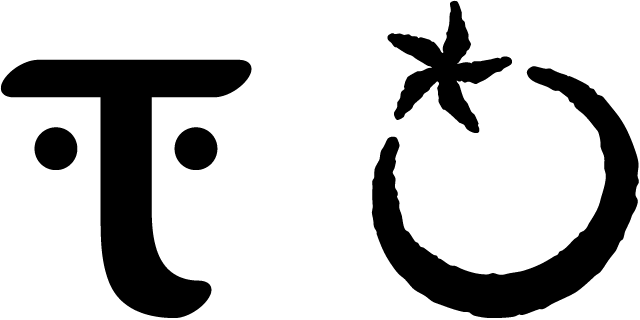Come si intrecciano i ricordi personali della propria infanzia con la storia e la memoria di una migrazione? Paula Tushi ci conduce nella vita ai margini delle grandi città vissuta dall’immigrazione albanese in Italia, con una riflessione che intreccia le aspirazioni delle seconde generazioni con una condizione di “doppia assenza”: non si è mai abbastanza albanesi in Albania e non si è mai sufficientemente italiani in Italia.
Quando socchiudo gli occhi mi si palesa davanti il richiamo della moschea a mezzogiorno, i cani randagi e i bambini romanes che fanno la questua. Il ricordo a cui sono più affezionata è quello di mia nonna che mi legge il fondo della tazzina di caffè – rigorosamente preparato con la cezve – il suo sguardo concentrato a decifrare le figure misteriose createsi dall’allinearsi casuale dei chicchi rimasti in fondo alla tazzina. Nella camera da letto dei miei nonni c’è una foto di Enver Hoxha affissa al muro, occupa il posto che di solito spetta alla foto di famiglia, di quelle che danno una parvenza di felicità. I miei ricordi legati all’Albania non sono esattamente ricordi in senso stretto, sono sensazioni che riemergono dal sottosuolo, sono confusi e incompleti.
La mia memoria è indissolubilmente legata all’Italia, alle grandi stazioni ferroviarie, all’autostrada che collega Firenze a Bari, dove scendevo ogni estate con la mia famiglia per prendere la nave che ci avrebbe riportato là, sull’altra sponda dell’Adriatico. Avevo spesso il presentimento che neanche i miei genitori volessero realmente tornarci, ma il senso di dovere verso chi era rimasto dall’altra parte si faceva pressante prima o poi.
La parte più vivida dei miei ricordi prende forma in Italia, in un campo di migranti tutti provenienti dall’est Europa. Eravamo sistemati tutti quanti in delle roulotte vicino a un fiume.
Le notti erano umide e le giornate interminabili, così noi bambini ci inventavamo ogni sorta di diavoleria per passare il tempo: dalle gare clandestine sui motorini con dei ragazzi più grandi, al rincorrerci per il campo facendo chiasso. Ricordo che rubavo spesso nei negozi, piccoli oggetti senza chissà quale valore, che però desideravo ardentemente. La roulotte non era attrezzata per il bagno, dunque i nostri bisogni finivano in una bacinella che veniva di ora in ora svuotata e pulita.
Per fare la doccia, bisognava andare in un palazzo di fronte, dotato di bagni pubblici. Non negherò che la mia attività preferita in estate era lavarmi i capelli sotto una fontanella lì vicino. Noi bambini vivevamo come in un gioco, senza porci troppe domande circa il contesto che vivevamo.
Il mondo degli adulti era fatto di sussurri, frasi laconiche, sguardi melanconici e umori altalenanti dovuti alla loro condizione di doppia assenza: non padroneggiavano abbastanza bene l’italiano né possedevano una qualifica particolare per essere cittadini attivi, ed erano ormai lontani dalla terra in cui potevano muoversi con l’attitudine di chi vi riconosce casa propria.
La mia sensazione era simile a quella che l’antropologo Sharam Khosravi delinea in Io sono confine: «Il vecchio muore e il nuovo non può nascere; in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati».
Ricordo come le persone intorno a noi si dividevano in due perfette categorie: chi ci sosteneva, le parrocchie, la Caritas, e poi c’erano quelli timorosi, spaventati da un’ etnicità sopra le righe, dai vestiti di seconda mano, da gente che era arrivata «col barcone». Era difficile interagire nella Firenze dei primi anni 2000 con persone del posto, se eri uno straniero.
Era complicato farsi degli amici ed inserirsi in quel mondo così composto, così come era complicato nascondere il proprio accento o non sbagliare un congiuntivo.
Allora non avevo nessuno strumento per capire quanto fosse fuori dalla norma il tipo di vita che conducevamo; ad ogni modo per me le scorribande con mia cugina e quei ragazzi più grandi erano la panacea di tutti i mali. Fu più tardi che tutto divenne più limpido. Cambiando casa popolare di tanto in tanto, mi rendevo conto che la vita degli stranieri si situava ai margini della città, nella periferia, dove finivamo per conoscere altri migranti dalle nazionalità più svariate. Intanto, i miei genitori litigavano spesso, per questioni finanziarie, per l’assenza di sicurezze, per la marginalizzazione emotiva, per non riuscire a comunicare nonostante dopo un po’ si parlasse la stessa lingua del paese che ci ospitava.
Il legame con il dolore dei genitori, che parla allo stesso tempo di una distanza da esso non avendolo vissuto in prima persona si costituisce allora come una fondamentale eppure confusa connessione con la generazione precedente.
Ernst Van Alphen, 2006
Un giorno qualunque a casa, rovistando tra vecchi averi mi imbattei in un piccolo libretto dal colore rosso sbiadito con delle scritte che da subito attirarono la mia attenzione: «SFR Jugoslavia».
All’interno, a mia sorpresa, c’era anche una mia foto da piccola accanto a quella di mio fratello.
Entrambi con nomi e cognomi differenti, un’altra nazionalità e altre date di nascita.
Fu in quel momento che capii che quel piccolo libretto rosso era un passaporto jugoslavo falsificato, il nostro lasciapassare per l’Italia. Era come se prima di quel passaporto io avessi sempre avvertito una conflittualità identitaria, una specie di bipolarismo ingiustificato. Dopo essermi vista con un nome diverso non ho potuto fare a meno di capire che tale sensazione era sempre stata giusta.
In un certo senso, quel libretto rappresentava simbolicamente la nostra maschera, quella adottata per attraversare un confine, ma allo stesso tempo era paradigma dell’identità malleabile e negoziabile tipica delle soggettività migranti. Da quel momento, una parte di me non ha mai smesso di essere Anila, una bambina kosovara.

Con queste esatte parole mia madre incalza un amico di famiglia quando ci chiede come sia andato l’ultimo viaggio in Albania che abbiamo fatto nell’ottobre 2022. Durante il nostro soggiorno lei non riconosceva più le strade della città in cui aveva studiato, era tutto molto confuso, le persone si rivolgevano a noi in inglese pensando fossimo turiste. Spesso negli anni mi è capitato di non essere «abbastanza» albanese in Albania – «Parli con uno strano accento» – e neanche «abbastanza» italiana in Italia.
Mi chiedevo a cosa servisse studiare tutta quella storia su Roma e gli imperatori, imparare a memoria i versi di Dante, quando ero de facto esclusa dalla cittadinanza.
Allo stesso tempo non avevo nessuna percezione della storia o della letteratura dell’Albania. Esisteva una letteratura albanese? Aveva avuto qualche autore importante e riconosciuto universalmente?
Tutte domande a cui ho risposto da sola, nel tempo.
Crescendo però mi rendevo talvolta conto che questo sentimento non era sempre così ovvio.
Vedevo mio fratello dimenticare piano piano la sua lingua madre, rispondere solo in italiano anche all’interno del contesto domestico. Non avvertiva più l’esigenza di mantenere vivo quell’universo simbolico che semplicemente non trovava alcun riscontro in questa nuova realtà.

Pasqua 2023, andiamo a mangiare fuori in famiglia. Sono occasioni uniche, in cui si intrecciano racconti di vita sotto il comunismo, barzellette e ricordi un po’ melanconici. Guardandosi intorno i miei genitori non riescono a fare a meno di sottolineare come gli italiani «siano molto composti a tavola» e notino «se non sei altrettanto composto». Mio fratello incalza la discussione dicendo che durante il suo soggiorno alla Madonnina del Grappa (istituzione ecclesiastica che fra le altre cose ancora oggi bambini migranti a Firenze) furono proprio le suore a «insegnarmi le giuste maniere di stare a tavola, altrimenti non saprei come stare composto». Mia zia ribadisce che pure sua figlia, mia cugina, ha imparato come stare a tavola durante il loro soggiorno in una casa famiglia.
Io ascolto attentamente e una smorfia si allarga sul mio viso, perché mi rendo conto che sono quella più scomposta, sgraziata e impacciata a tavola.
Tendenzialmente la memoria è un concetto che lega inesorabilmente al passato, con la pretesa non detta di mantenere vivido qualcosa che si è vissuto. La memoria, però, può anche essere un’occasione di rinascita. I figli della diaspora sono portatori spesso inconsapevoli del dolore vissuto dai genitori, ma sono anche nuove persone con una propria agency. La possibilità dell’oblio nel faticoso esercizio di ricordare è sempre in qualche modo presente, e c’è sempre un divario fra coloro che vogliono dimenticare e coloro che vogliono ricordare.
La cultura spesso e volentieri si manifesta come una categoria mutilante e gli individui non rappresentano mai la propria cultura tout court, ma al tempo stesso è razzista negare alle persone la produzione di significati propri del mondo in cui sono cresciute e di cui sono portatrici. Estromettere dalla storia certi comportamenti, così come un intero processo migratorio, per relegarli alla dimensione naturale dell’individuo o dell’etnia è una forma subdola di percepire l’altro.
A volte non riesco a fare a meno di pensare a una parola appresa durante le lezioni di tedesco al liceo, una parola che rappresenta un concetto ormai universalmente conosciuto: Heimweh.
Venne introdotto da medici e scienziati nel ’600 per indicare delle morti misteriose e diserzioni da parte dei soldati, e dopo un’attenta rielaborazione assunse caratteri patologizzanti che sfociarono nel profilo della «Nostalgia». L’idea quasi romantica della nostalgia di casa mi ha sempre affascinato. Mi piaceva l’idea di avere un luogo incastonato nel cuore che ti facesse venire il desiderio di tornarci, ma quelle volte che tornavo in Albania, mi rendevo conto che non condividevo molto dei miei modi di fare con le persone che vivevano lì. Non sapevo che genere di cose i ragazzi guardassero in televisione, quale musica ascoltassero, quale passatempo avessero. La mia nostalgia era dunque solo un’idealizzazione di un luogo che io volevo mi appartenesse a tutti i costi? Forse mi sentivo intimamente traditrice nel preferire l’Italia e i suoi agi, le strade asfaltate e i programmi patinati della domenica mattina. Ad ogni modo, mi sforzavo spesso di sentire nostalgia verso quel paese che desideravo ardentemente fosse anche mio, perché ne conoscevo la lingua, perché il mio cognome tradiva la mia «appartenenza» o banalmente perché, seppur senza una coscienza politica, mi dicevo che «essere più cose all’unisono è meglio che essere una sola cosa e basta».
A volte cerco di sfoggiare un’identità balcanica «autentica», citando qualche nozione storica letta e appresa qua e là, una poesia di Ismail Kadarè imparata a memoria e parlo del profumo intenso dei baklava al pistacchio – «Hajde moj Paula, hajde»* – mi dicono i miei genitori, stupiti da questo processo di riappropriazione identitaria.
Immagine di copertina: foto di una giovane "contadina" alla festa ortodossa di San Giovanni a Shijon, vicino Elbasan, Albania, 1929. Fotografo: Hugo Benatzik. Fonte: profilo Instagram Balkanism.
*Letteralmente: «vieni, Paula, vieni». Può essere intesa come un’esclamazione di sorpresa di fronte a qualcosa di inaspettato, generalmente con valore positivo.
Paula Tushi si è laureata in Antropologia, religioni, civiltà orientali all’Università di Bologna. Attivista per i diritti umani, ha viaggiato e vissuto fra il Sud America e il Nord Africa, per poi stabilirsi a Palermo, dove collabora con associazioni locali come fotografa. Si interessa di migrazioni e del rapporto fra memoria, cultura e diaspora nei Balcani.