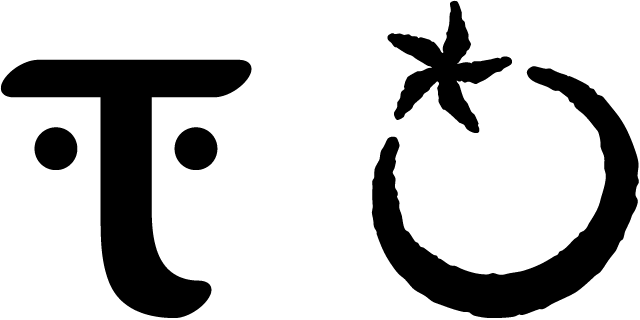A metà tra madri e figlie, l’iper-responsabilizzazione delle donne migranti
Donne, madri, figlie, migranti: la sovrapposizione di queste identità produce delle esperienze peculiari di migrazione. Sospese tra le responsabilità che le legano sia al paese di origine che a quello ospitante, le donne migranti vivono a metà tra due mondi, spesso in contrapposizione. Cinque interviste hanno portato alla luce le criticità, i dubbi e le sfide che le madri-migranti si trovano ad affrontare tra la cura della famiglia lontana e vicina, tra incertezza ed empowerment.
Tuttavia i flussi migratori, sempre in cambiamento, hanno manifestato nel 1990 una forte inversione, in seguito ad un trend di crescita durato decenni. Abbiamo assistito a una vera e propria femminilizzazione dei flussi: per la prima volta la percentuale delle donne migranti è divenuta pari quella degli uomini migranti (49% di donne, 51% di uomini; tali percentuali cambiano a seconda della regione di riferimento). Soprattutto, questo dato, che a un primo avviso ha l’aria di essere semplicemente numerico, porta con sé una serie di conseguenze più o meno importanti. Se il migrante si trova al centro di una rete di rapporti transnazionali (ossia di relazioni e comunicazioni che uniscono gli individui dallo stato di partenza a quello di arrivo), l’aumento della componente femminile di migranti ha mutato notevolmente i pattern ravvisabili in questi network, infatti, come segnala il sociologo Paolo Boccagni, «le madri migranti che hanno lasciato nel paese di origine gli altri membri della famiglia attivano pratiche transnazionali molto intense soprattutto sul versante emotivo-relazionale, molto più accentuate e problematizzate rispetto ai migranti uomini/padri».
Una prima differenza da sottolineare è che le donne migranti hanno iniziato a ricoprire nuovi ruoli lavorativi, tendenzialmente legati alla cura e molto differenti da quelli scelti fino a quel momento dagli uomini, tradizionalmente più legati alla forza (soprattutto all’edilizia e ai lavori pesanti legati al primario). Donne provenienti dall’Est Europa, dal Sud America e dall’Africa hanno iniziato a trovare lavoro come badanti, baby-sitter e domestiche. Tra le conseguenze più interessanti di questo nuovo dato vi è, senza dubbio, il fatto che questo nuovo tipo di offerta di lavoro ha permesso alle donne dei paesi di arrivo di dedicarsi maggiormente alla propria vita lavorativa e privata, avendo delegato la responsabilità della cura della casa e della famiglia a queste nuove figure. Allo stesso tempo però,la cura si è consolidata in un vero e proprio lavoro retribuito su cui le donne migranti possono contare. Rappresenta, infatti, un tipo di mansione di cui c’è quasi sempre una domanda nei paesi occidentali, in cui le donne sono impegnate in altri lavori e non possono dedicarsi alla famiglia. Oltre a ciò, le donne migranti, che nei propri contesti di provenienza spesso si occupavano proprio di accudire giovani e anziani, hanno già le «capacità» necessarie per ricoprire questi ruoli. Ruoli che, tuttavia, per la prima volta diventano fonte di uno stipendio, permettendo l’indipendenza delle donne migranti rispetto alla famiglia di provenienza.
Ma chi sostiene questo stipendio? Spesso le donne migranti intraprendono il progetto migratorio insieme ai propri bambini, o, ancora, scelgono di diventare madri nel paese di accoglienza. Questo aspetto cambia enormemente l’andamento, la forma e le responsabilità che la migrazione si porta dietro. Queste donne si trovano spesso a svolgere dei lavori di cura retribuiti per i propri datori di lavoro, ma devono anche dedicare tempo alla propria famiglia. Se è più facile dedicarsi alla famiglia a cui sono fisicamente vicine (generalmente figli e marito), risulta molto più difficile per quanto riguarda la parte di famiglia che rimane nel paese di provenienza (in particolare i genitori, ma si fa riferimento qui anche alla famiglia allargata). Non è raro, come è stato messo in luce nelle interviste condotte, che queste donne siano colpevolizzate dai propri familiari per il fatto di essere partite e di non essersi assunte la responsabilità di curare i propri anziani. Nonostante ciò crei un’enorme pressione psicologica sulle donne migranti, è anche vero che questa viene mitigata dagli aiuti economici che esse sono in grado di mandare a casa grazie ai lavori che le tengono lontane, tratto comune alle donne intervistate provenienti da culture diverse.
Ma come vivono le donne migranti il proprio ruolo a metà tra madri e figlie, dovendo fare anche i conti con la distanza di una parte della famiglia? Se la distanza è un peso psicologico in sé, acuisce anche la difficoltà del ruolo genitoriale. Mi chiedo: che ruolo deve giocare la cultura del paese di provenienza? Che ruolo deve giocare la cultura del paese di arrivo? Per valutare al meglio le esperienze di vita di chi intraprende questo percorso migratorio, ho intervistato cinque donne provenienti da luoghi diversi, con l’obiettivo di cercare di mettere in luce le similitudini che accomunano il vissuto di alcune donne migranti. I nomi rimangono anonimi, hanno tutte dai quaranta ai cinquant’anni. Due vengono dal Sud America (Argentina e Perù), una dall’Est Europa (Ucraina) e due dall’Africa (Senegal e Ghana): le indicherò con l’iniziale puntata del loro paese.
Il rapporto con la famiglia nel paese di provenienza: la lontananza dei cari
Per quanto riguarda la lontananza dalla famiglia, essa rappresenta per prima cosa un fattore psicologico: non poter parlare la propria lingua, non poter celebrare alcune usanze, non poter partecipare al processo di crescita collettiva del nucleo familiare sono un duro colpo per i migranti. Per le donne, nello specifico, la lontananza viene spesso vissuta come la colpa di non stare adempiendo alle proprie responsabilità nei confronti della famiglia. Le donne migranti quindi si trovano sospese tra questo senso di colpevolezza e di mancanza e una rinnovata consapevolezza di poter aiutare la famiglia diversamente, spesso anche sentendosi più autonome e indipendenti di quanto si siano mai immaginate. Dalle risposte a questa domanda è risultato che la possibilità di aiutare i propri cari risulta come un vero e proprio senso di empowerment. P. afferma infatti che «noi, persone che migriamo, lo facciamo per poter aiutare la nostra famiglia, che siano i genitori o i figli».
In alcuni casi, però, il peso di dover aiutare risulta paralizzante e genera un senso di ansia che a volte porta all’allontanamento dalla famiglia. È il caso di S., che a tal proposito dice: «A volte non possiamo occuparci nella nostra famiglia, perché non possiamo occuparci di tutti i problemi di cui ci parlano. Anche nel momento più difficile per noi, essendo noi in Europa e quindi in una situazione migliore, abbiamo dovuto inviare degli aiuti a casa». Si parla di un vero e proprio senso di impotenza che finisce per ledere i legami transnazionali dei migranti: si diradano le chiamate e i contatti cercando di concentrarsi sui problema personali ed immanenti, a causa dei quali è impossibile anche solo pensare di aiutare altri.
In altre situazioni, invece, gli aiuti inviati a casa non rappresentano un peso, né tantomeno un obbligo o una necessità. Si tratta di un vero e proprio love language, un regalo gentile per rafforzare i legami e «restituire» a casa il favore del supporto ricevuto durante le prime fasi della migrazione. U. infatti dice: «Provo a parlare con loro tutti i giorni, informandomi su come è andata la loro giornata, se ci sono stati bombardamenti nella nostra città o se è rimasto tutto tranquillo. Gli mando soldi tutte le settimane, anche se so che a loro non servono, ma lo faccio perché posso e perché voglio rendere la loro vita migliore e più semplice. Hanno supportato il mio trasferimento in Italia con i bambini, ma loro non vogliono lasciare l’Ucraina».
Il rapporto con la famiglia nel paese d’arrivo: tra un nuovo inizio e la costruzione del futuro
Una volta risolto il rapporto più o meno conflittuale con la famiglia lontana, tra disaccordi, supporti e risorse, rimane il rapporto con la famiglia che si crea nel paese di arrivo. Le situazioni possono variare di molto: alcune donne seguono il marito dopo che quest’ultimo è riuscito a trovare una situazione stabile, altre migrano autonomamente con i propri figli, altre volte ancora intere famiglie partono contemporaneamente. Anche per quanto riguarda i figli le situazioni possono essere differenti. Ci si può trasferire con figli adolescenti oppure molto piccoli, o, ancora, a volte i figli nascono nel paese d’arrivo.
Le differenze elencate influiscono sensibilmente sul comportamento che la famiglia ed in particolare la madre migrante adotta. Tuttavia, su un aspetto tutte le situazioni finiscono per assomigliarsi. Tra le responsabilità di una madre migrante c’è la crescita e l’educazione dei propri figli, che a seconda del caso, è affrontata da sola, con il proprio marito o in un nucleo alternativo. E, ovviamente, nell’educazione rientra anche l’insegnamento delle tradizioni, della storia e delle arti del paese di provenienza: una vera e propria sfida per le madri migranti, già talvolta alle prese con la conflittualità dei rapporti con i figli, che vedono concretizzarsi così il rischio che essi non approfondiscano o addirittura respingano la cultura d’origine.
Un'altra casistica infatti è che i figli migranti, pur di integrarsi nella società in cui sono cresciuti o addirittura nati, decidano, più o meno coscientemente, di rifiutare la cultura dei propri genitori. A tale proposito S. afferma: «Per quanto riguarda la cultura, è molto difficile, nel senso che se anche noi proviamo a parlargli in alcuni dialetti o lingue nostre africane, i nostri figli cercano invece di esprimersi sempre in italiano. O addirittura quando gli cuciniamo i nostri piatti tipici, non gli piacciono perché non sono abituati ai sapori. Però cerchiamo di crescerli con una mentalità e una buona educazione che li porti ad aiutare la propria famiglia e la propria comunità».
In altre testimonianze invece, le culture coesistono meno problematicamente, senza che necessariamente si debba scegliere tra l’una o l’altra, come accade nel caso di P. Emblematica è la sua testimonianza: «Per quanto riguarda la cultura, credo che chi emigra debba familiarizzare con la cultura e rispettarne le leggi. Il Sudamerica, dove sono nata e cresciuta, è un luogo profondamente diverso. Abituarsi è molto difficile, ma nel frattempo… Non permetterò a nessuno di mancarmi di rispetto. A volte è difficile perché abbiamo due culture diverse: abbiamo bisogno di più empatia».
Ci sono poi madri migranti per cui tramandare la cultura del proprio paese d’origine non rappresenta un passaggio necessario nella crescita dei propri figli. A. confessa, ad esempio: «Non ricordo di avergli insegnato le nostre tradizioni, gli racconto alcune cose ma, a causa della lontananza, è impossibile spiegargli tutto. Piuttosto, faccio di tutto per fargli vivere una vita migliore qui». Si intuisce quindi che il miglioramento di vita non passa necessariamente attraverso la conoscenza delle radici, anche a causa di una vera e propria mancanza di tempo, ma piuttosto attraverso un miglioramento delle condizioni materiali di vita e di possibilità future.
Al contrario però, esistono anche situazioni in cui il processo migratorio ha unito maggiormente delle famiglie. Lo racconta l’esperienza di U., per cui «i rapporti sono andati solo meglio da quando ci siamo trasferiti, perché capiamo che siamo le persone più importanti gli uni per gli altri». Oltre alla rinnovata unità, il processo migratorio ha fornito anche un’occasione per insegnare ai propri figli la cultura d’origine, investendo nel capitale umano sia attraverso un’istruzione sempre più alta sia attraverso il riavvicinamento alle «radici». Circa quest’ulteriore aspetto, U. continua: «Insegno loro la cultura del nostro paese, così non dimenticano da dove vengono, così ricorderanno le loro ‘radici’. Festività, mitologia, letteratura dell’Ucraina – tutto ciò è parte integrante della nostra vita. Due delle mie figlie si sono già laureate all’università, ma la più piccola va ancora a scuola (ha undici anni). Le pago dei tutor sia di italiano sia di inglese per farla sentire più a suo agio tra gli altri bambini e a scuola, faccio del mio meglio per farla sentire a proprio agio in Italia».
A metà tra due mondi: lo spazio per sé
Uno dei motivi per sono state condotte queste interviste è stata la sensazione che il discorso sulla migrazione non si soffermi abbastanza sulle conseguenze del ruolo familiare della madre e sulle sue specificità di genere. Esperienze molto differenti hanno pur contribuito a ricostruire un quadro molto simile: le donne migranti ricoprono un ruolo molto importante di continuità tra la comunità del paese d’origine e quella del paese d’arrivo. Ruolo così importante che porta spesso ad una vera e propria iper-responsabilizzazione di queste donne, che mettono da parte i propri desideri e le proprie difficoltà per adempiere ai propri compiti. Questa è una realtà diffusa, condivisa da quattro su cinque intervistate, con l’unica eccezione di U. che afferma che «i miei figli mi supportano, i miei genitori mi supportano. Sono comprensivi in quei momenti in cui è difficile per me e fanno il possibile affinché io non mi dimentichi che sono una donna. Sono estremamente fortunata con la mia famiglia». Anche in questo caso però, è forte la sensazione di trovarsi a metà, aggiunge: «Non è facile muoversi dal posto in cui hai vissuto tutta la vita. A volte i miei figli ed io vogliamo solo tornare a casa in Ucraina, ma poi ci ricordiamo perché ce ne siamo andati».
Per altre donne che non hanno invece mai davvero conosciuto un momento di vera e propria autonomia, anche l’esperienza migratoria in sé risulta come un arricchimento appagante. È l’impressione che ha avuto P: «Sto studiando e imparando una nuova lingua per me e questo mi fa sentire bene individualmente ma in realtà mi sento sospesa tra due mondi diversi, sia per quanto riguarda la lingua, sia per la cultura... Ma ogni giorno che passa e io sono qui cerco il modo per integrarmi nella società italiana ed è meraviglioso per me»...
Tuttavia sono le poche e significative parole di A. che hanno ispirato l’intera riflessione. Ridendo come se le avessi chiesto qualcosa di sciocco e poco plausibile, alla domanda sul rapporto con se stessa risponde: «Quando uno ha figli no existe espacio para una, perché vive per loro. Quale spazio per me? Non esiste». E se questa affermazione potrebbe sembrare pronunciata da qualsiasi donna del mondo alle prese con il conflitto tra maternità e cura personale, nel caso delle donne migranti lo spazio per sé si riduce pericolosamente ancor di più, fino, in alcuni casi, a scomparire.
*Illustrazione di copertina di Sara Marseglia
Sara Marseglia è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Orientale di Napoli. Al momento, frequenta la magistrale Informazione, Culture e Organizzazione dei Media all’Alma Mater di Bologna. Si occupa di ricerca sui media digitali e Internet culture. Scrive per «Scomodo» e «Informare Magazine».