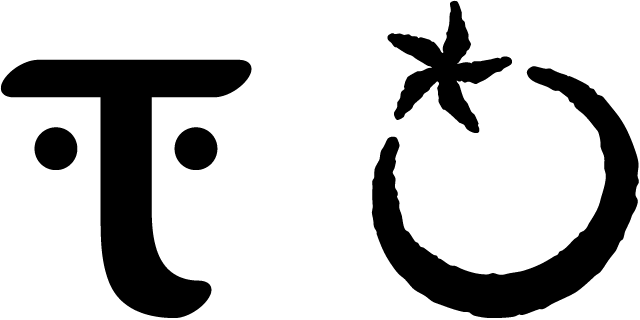Cosa rende le persone con disabilità un po’ meno «persone» delle altre?
Quando si parla di accessibilità, spesso le persone disabili appaiono schiacciate nel loro ruolo di corpi–menti difformi, il cui unico scopo è riuscire a raggiungere un posto o usufruire di un servizio. In questo articolo si indaga invece come l’inaccessibilità degli spazi per le persone disabili sia la conseguenza di un modello di spazio profondamente abilista che produce enormi discriminazioni.
Qualcosa di simile accade ogni giorno sotto i nostri occhi, perfino nella città italiana con la miglior qualità della vita, dove c’è una parte della popolazione che resta esclusa dal 73% di negozi e locali. Ed è realistico immaginare che il dato sia ben peggiore in altre località. Eppure la questione non crea particolare scandalo perché riguarda una categoria che fatichiamo non solo a notare ma anche a immaginare, quando pensiamo a chi attraversa gli spazi pubblici: le persone con disabilità.
Le barriere architettoniche e percettive sono ovunque e le norme non sembrano bastare. Due anni fa il Comune di Bologna ha provato ad affrontare il problema con un innovativo regolamento, che chiede a tutti i luoghi aperti al pubblico di rendere accessibile almeno l’ingresso entro il 2023: ma la maggior parte dei soggetti obbligati non sa nemmeno della sua esistenza. Nel 2015 Milano aveva emanato un regolamento ancora più semplice che chiedeva solo di avere una rampa mobile, eppure solo un locale su dieci l’aveva comprata.
L’esperienza di non poterci muovere fuori di casa o frequentare locali e negozi è diventata temporaneamente collettiva durante i lockdown: abbiamo improvvisamente provato cosa significa non poter andare a una cena con gli amici o fare colazione al bar. Pur sapendo che era una condizione temporanea, necessaria a tutelarci da conseguenze gravi, molte persone l’hanno sofferta come una pesantissima violazione della propria libertà.
Questo tipo di esclusione invece non fa notizia: l’inaccessibilità è stata normalizzata. Il fatto che una persona in carrozzina non possa prendere un caffè, fare la spesa o entrare in casa di un* partner a causa di gradini non ci stupisce. Non scendiamo in piazza per protesta quando a una persona cieca viene impedito di attraversare la strada perché il semaforo non ha segnali acustici. Come è possibile? Cosa ci ha permesso di smarrire quello che la sociologa Tanya Titchkosky chiama il «senso di emergenza» di fronte a una discriminazione palese e costante? Cosa rende le persone con disabilità, in fondo, un po’ meno «persone» delle altre?
A che servono le scale?
Tobin Siebers, uno dei più importanti accademici nell’ambito dei disability studies, lo spiega bene nel suo Disability theory attraverso la storia del Galehead Hut. Si tratta di un rifugio sugli Appalachi che venne costruito nel 2000, ma senza rispettare la normativa americana sulle barriere architettoniche. Di fronte alle proteste di alcune persone disabili, i proprietari si difesero: il rifugio è raggiungibile solo tramite un ripido sentiero per scalatori, a cosa servirebbe l’accessibilità? Per sfidare questo preconcetto, un gruppo composto da tre escursionisti in carrozzina e due con stampelle percorsero il sentiero e riuscirono a raggiungere il rifugio. Un giornalista che seguì la vicenda chiese loro: «Se siete in grado di trascinarvi su per i sentieri, non potreste superare anche le scale del rifugio?». Uno di loro rispose: «Allora perché preoccuparsi di creare un ingresso con le scale? Potreste arrampicarvi ed entrare dalle finestre».
La vicenda evidenzia come tutte le persone, anche quelle non disabili, abbiano in realtà bisogni di accessibilità: non li consideriamo tali perché ci sembra ovvio che i bisogni del modello «standard» di essere umano debbano trovare risposta. E ci sembra altrettanto legittimo che chi si discosta da questo modello si debba invece arrangiare.
Questa è una delle sfaccettature dell’abilismo, cioè il sistema di pensiero che dà per scontata l’esistenza di un modello «normale» di corpo-mente, e da cui derivano le discriminazioni verso le persone con disabilità. Tutte le persone, comprese quelle che hanno una disabilità, sono cresciute in una cultura più o meno abilista, perciò decostruire quel modello richiede parecchia fatica. È difficile disimparare quello che sappiamo sui corpi-menti, specialmente se il mondo attorno a noi ci ripete tutti i giorni – tramite ogni gradino di marciapiede, ogni film senza sottotitoli – che la presenza di alcuni esseri umani è prevista, attesa e legittima, mentre quella di altri non lo è.
Essere consapevoli del modello abilista è importante nel ragionare di accessibilità, perché aiuta a mettere nella giusta prospettiva una delle obiezioni più comuni: i costi. È stato sottolineato che progettare in modo accessibile fin dall’inizio non aumenta i costi in modo sostanziale; il problema in genere è il retrofitting, cioè l’adattamento di luoghi e servizi non pensati, in origine, come accessibili. In realtà, anche per la rimozione delle barriere esistenti vi sono una serie di agevolazioni: è stato rinnovato fino al 2025 il bonus fiscale del 75% per chiunque (anche se non ha una disabilità) rimuova barriere architettoniche in casa o nel proprio negozio; nel caso di edifici residenziali è possibile accedere ai contributi di cui alla legge 13/1989 e ad altri contributi che dipendono da regione a regione.
Ma qualsiasi agevolazione sia prevista, il costo per la rimozione delle barriere sarà sempre considerato eccessivo se si parte da una prospettiva abilista. Per capire di cosa si tratta, pensiamo a com’è fatta un’aula universitaria: ci aspettiamo di trovare sedie per gli studenti, illuminazione e proiettore. Sono dispositivi che rispondono ai bisogni di accessibilità di un particolare tipo di essere umano, che ha bisogno di sedersi e di accendere la luce per orientarsi. Per assurdo, se lo «studente base» immaginato fosse in carrozzina, si potrebbe risparmiare sull’acquisto di sedie. Titchkosky osserva che è ritenuto ovvio e indispensabile spendere per i bisogni di accessibilità delle persone normodotate: se non hai i fondi per le sedie, forse devi ammettere che, in quel momento, non sei pronto ad allestire un’aula universitaria.
Se invece mancano i soldi per un ascensore o un interprete della lingua dei segni, l’aula viene considerata comunque utilizzabile: l’accessibilità non è vista come un requisito ovvio, ma come un «di più», la cui legittimità può essere oggetto di lunghe negoziazioni e di compromessi. Nel frattempo, le persone disabili possono aspettare fuori.
Rimuovere le barriere non è scontato perché non è scontata la presenza delle persone disabili. La loro possibilità di esistere e di muoversi nello spazio è subordinata al fatto che venga loro concesso da parte di chi detiene il potere su quello spazio: in genere, persone senza disabilità.
Le norme sulle barriere architettoniche
A delimitare i confini di questa concessione – tramutandola almeno entro quei confini in un diritto – è intervenuta la normativa. Nel senso comune, si tende a credere che l’accessibilità coincida con la norma giuridica, ma in realtà il termine «accessibile» viene usato in molti modi diversi. A volte indica l’aderenza alle norme, altre invece rappresenta l’esperienza di una o più persone con disabilità, che possono ritenere un luogo accessibile o meno, indipendentemente da quanto esso risponda alle norme.
I due significati sono diversi ma strettamente intrecciati, perché anche le norme derivano, in qualche modo, dall’esperienza delle persone con disabilità. Rappresentano infatti una cristallizzazione – avvenuta in precisi luoghi e momenti storici – di quella che Hamraie chiama access knowledge, conoscenza sull’accessibilità, stratificatasi negli anni attraverso un mix di studi più o meno scientifici (non molti in realtà), consulenze di esperti e attività di pressione svolte da organizzazioni di persone disabili. Anche le norme riflettono quindi determinate idee su «chi sono» le persone disabili, che tipo di disabilità hanno e come ci aspettiamo che si muovano nello spazio. Ad esempio, sono molto rappresentate le esigenze di chi usa una carrozzina, e in parte quelle delle persone cieche; molto meno quelle delle persone sorde o neurodivergenti.
Ad oggi, in Italia, molti aspetti dell’accessibilità sono regolati da norme tecniche dettagliate; altri possono rientrare nelle leggi più generali che vietano la discriminazione delle persone disabili. Le norme tecniche ad oggi vigenti risalgono al 1989 e riguardano sia spazi pubblici (come le strade e marciapiedi) che spazi privati, come case e condomini, o anche privati aperti al pubblico, come negozi e ristoranti.
Ma se le norme esistono da quasi 35 anni, come si spiega che per una persona disabile sia così difficile anche solo prendere un caffè? Avere una rampa in bar non è forse obbligatorio? E non sarebbero dovuti anche altri accorgimenti per l’accessibilità, come offrire un menù in Braille per chi non vede, o limitare il volume delle musica di sottofondo nei locali, per consentire alle persone ipoacusiche di comprendere una conversazione?
Dal punto di vista del diritto, la risposta è «dipende». Nel nostro Paese, l'accessibilità degli edifici privati è stata regolamentata dal Dm 236/89. Il decreto offre anzitutto una definizione di «barriere architettoniche»: a differenza di quanto si pensa comunemente, il termine indica non solo gli ostacoli per chi ha una disabilità fisica, ma anche la mancanza di segnalazioni che permettano l’orientamento a chi ha una disabilità sensoriale.
Per gli edifici privati aperti al pubblico – come appunto un bar – costruiti o ristrutturati dopo il 1989, la norma richiede la visitabilità, cioè l’accessibilità degli spazi principali del locale e di un bagno. Per gli edifici precedenti al 1989 il dm richiede solo la «visitabilità condizionata», ovvero la presenza di un campanello all’esterno per chiedere l’aiuto del personale. Basta però fare una passeggiata in qualsiasi strada urbana per notare che anche un adattamento così minimale è stato applicato da pochissimi negozi.
Ma è davvero solo questo il requisito da rispettare negli edifici pre-1989? Non proprio. Oltre a eventuali norme aggiuntive a livello locale, deve essere rispettato il divieto di discriminazione sulla base della disabilità, imposto, successivamente al Dm 236/89, dalla legge 67/2006 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd) che l’Italia ha ratificato nel 2008, rendendola una propria legge.
Il divieto di discriminazione
È ormai assodato nella giurisprudenza che le barriere possono essere causa di «discriminazione indiretta», cioè quella generata da una situazione «apparentemente neutra» che però pone una persona in una situazione di svantaggio, per via della disabilità. Ad esempio, l’Atac è stata condannata per discriminazione indiretta per il malfunzionamento degli ascensori nelle stazioni della metro, così come il Comune di Roma per l’inaccessibilità di un ponte pedonale.
Ma in quali casi la mancanza di accessibilità può generare discriminazione? Se la barriera è stata creata dopo l’entrata in vigore di norme che la vietavano, la discriminazione è palese. Se l’ostacolo era invece già presente – come nel caso di un ristorante in un edificio precedente al 1989 e mai ristrutturato – una barriera può essere comunque discriminatoria se l’accessibilità poteva essere garantita tramite un «accomodamento ragionevole», che però non è stato realizzato (Lawson 2014).
L’accomodamento ragionevole è un concetto cruciale per comprendere i diritti delle persone con disabilità. Secondo l’art. 2 della Crp, comprende gli adattamenti che «non impongano un onere sproporzionato». Una parte del movimento delle persone disabili ha criticato questo principio, perché lascia ampio spazio all’interpretazione e rischia di limitare i diritti ogni qualvolta il loro costo venga ritenuto «sproporzionato».
S’intende che difficilmente un giudice potrebbe considerare sproporzionato lo sforzo di realizzare una breve rampa per superare un gradino; diverso potrebbe essere, ad esempio, richiedere l’installazione di un ascensore ad una piccola associazione culturale. Ma ancora diverso sarebbe il caso in cui quell’ascensore dovesse essere installato da parte di una pubblica amministrazione o di una grande azienda, che dispongono di ben altri mezzi economici.
In ogni caso, rispondere al quesito sulla proporzionalità dello sforzo richiede un’analisi del caso specifico da parte di un giudice. Infatti, un grande limite della normativa antidiscriminatoria è che può avere effetti solo se la persona discriminata decide di fare causa al soggetto che discrimina (per esempio, un locale inaccessibile). In genere si utilizzano i ricorsi ex legge 67/2006, «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni». Di solito si inizia con una lettera di diffida che chiede di rimuovere la barriera; spesso, specie se l’interlocutore è un soggetto privato, il problema viene risolto in questa fase (come è avvenuto per un camerino troppo stretto) tramite un accordo che può includere sia la rimozione della barriera che un piccolo risarcimento per coprire le spese per la diffida. Se la diffida non basta, si può procedere con il ricorso vero e proprio. Secondo la legge, può essere depositato in tribunale anche senza assistenza legale, ma normalmente conviene appoggiarsi a un avvocato o ad associazioni che offrono questo servizio, come la Ledha o l’Associazione Luca Coscioni.
Sarà il giudice a decidere se, nel caso specifico, sussiste discriminazione, valutando se era possibile mettere in atto un «accomodamento ragionevole» che invece non è stato realizzato. Se il tribunale riconosce la discriminazione, può ordinare che ne siano rimosse le cause (cioè ad esempio che sia tolta la barriera) e che la persona discriminata riceva un indennizzo (in genere di limitata entità: qualche migliaio di euro, più la copertura delle spese legali sostenute).
In Italia ci sono stati diversi ricorsi di questo tipo (qui una lista parziale), ma resta una via poco praticata: in parte per la scarsa conoscenza della norma, ma anche per la percezione che l’azione legale sia lunga, costosa e incerta. Per fare un confronto, negli Usa ci sono persone con disabilità che hanno fatto della lotta per l’accessibilità un mestiere: poiché lì le norme consentono di essere risarciti con relativa facilità, c’è chi si dedica a trovare barriere e farne ordinare la rimozione dai giudici, ricavandone di fatto uno stipendio.
Un sistema in cui l’unico modo per ottenere un diritto è rivolgersi a un tribunale, però, fa ricadere sulle singole persone l’onere di far applicare la legge. Alcuni comuni hanno provato a spostare tale onere sull’amministrazione: ad esempio Bologna aveva promesso controlli e sanzioni sulle attività aperte al pubblico – negozi, ma anche associazioni culturali o ambulatori medici – che non avessero sistemato l’ingresso entro settembre 2023, salvo impossibilità tecnica. L’applicazione delle sanzioni, però, è già stata sospesa. In effetti, in pochi erano davvero preoccupati: tanto c’è sempre una proroga, dicono, tanto nessuno fa davvero rispettare queste norme. Una previsione fondata sull’esperienza: è così da quasi 35 anni.
Nel frattempo, le persone disabili aspettano fuori.
A. Hamraie, 2017, Building access: Universal design and the politics of disability, University of Minnesota Press
A. Lawson, 2014, ‘Accessibility Obligations in the un Convention on the Rights of Persons with Disabilities’, South African Journal on Human Rights, 30(2), 380–392
T. Siebers, T, 2008, Disability theory, University of Michigan Press.
T. Titchkosky, T, 2011, The Question of Access: Disability, Space, Meaning, University of Toronto Press
Ilaria Crippi è nata a Ferrara nel 1988. Attivista disabile e lesbica, ha vissuto tra l'Emilia e il nord Europa collaborando con diverse organizzazioni per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Ha studiato come disability manager e progettista sociale, appassionandosi ai disability studies e alla ricerca emancipatoria. Si interessa in particolare di accessibilità e vita indipendente, che esplora intrecciando prospettive sociologiche e giuridiche. Quando può attraversa, e talvolta facilita, gruppi di confronto transfemministi e antiabilisti.